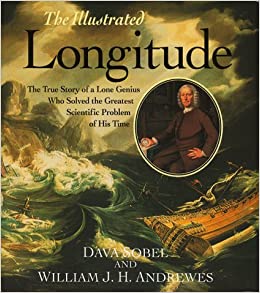Tornando al rapporto tra testo e immagine… nei mesi scorsi ho letto anche
The Illustrated Longitude di Dava Sobel e William J. H. Andrews. Il titolo e il doppio nome degli autori richiedono una spiegazione.
The Illustrated Longitude è infatti la versione illustrata del libro
Longitude (senza illustrazioni) di Dana Sobel, che ottenne una discreta popolarità al momento della sua uscita, nel 1995. La versione illustrata è stata pubblicata nel 1998, con la collaborazione di William J. H. Andrews e l’aggiunta di 180 immagini (questo è il numero dichiarato; non le ho contate, anche perché alcune sono presentate in varianti o duplicate, ma mi fido).
La pubblicazione di una versione illustrata ha senso. Non sono rari i casi in cui un testo praticamente chiede di avere immagini; eppure, le convenzioni editoriali e i problemi di costo e/o gestione dei diritti connessi fanno sì che molti testi abbiano meno immagini di quelle che molti lettori riterrebbero necessarie. E a monte, gli autori spesso non hanno cultura delle immagini, non sanno come fare a cercarle o sceglierle o riprodurle – e soprattutto, come usarle… Su problemi simili ragiono spesso a proposito di voci di Wikipedia. Nei prossimi giorni parlerò poi forse di un altro libro che non ha immagini ma che ne avrebbe vistosamente bisogno. Intanto, notiamo che, mentre si realizzano spesso edizioni di lusso con illustrazioni, casi come quello di Longitude, in cui le immagini sarebbero state necessarie fin dall’inizio, sono relativamente rari. Il testo di partenza, se ben capisco, includeva addirittura il confronto dettagliato di due ritratti di John Harrison… senza riprodurli. Un bell’atto di fede nel potere descrittivo delle parole – ma perché arrivare a questi punti?
Comunque, in entrambe le versioni Longitude racconta una storia interessantissima: quella dei tentativi di trovare un modo affidabile per determinare la longitudine. In un’era di GPS nei telefoni è difficile immaginarselo, ma fino alla fine del Settecento non esisteva un metodo affidabile per determinare la longitudine di una nave (o di un qualunque punto sul pianeta). Determinare la latitudine era relativamente semplice… bastava e basta misurare con precisione l’altezza del Sole nel punto più alto del suo percorso, a mezzogiorno… ma per la longitudine non esisteva nulla di equivalente.
Con questo rompicapo si misurarono alcuni dei principali matematici e astronomi dell’età moderna, da Galileo a Flamsteed. Tuttavia, una vera soluzione pratica arrivò solo nel Settecento, e da una via inaspettata: non attraverso calcoli matematici sui movimenti celesti (che comunque furono perfezionati in contemporanea), ma con la realizzazione di orologi tanto precisi e affidabili da permettere di capire con sicurezza quanto la nave si era allontanata dal meridiano di riferimento. A sviluppare simili meccanismi fu l’inglese John Harrison a metà Settecento, con un’impresa che richiese lunghi anni di lavoro – e anni ancora più lunghi per far riconoscere la bontà del sistema e ottenere la ricompensa messa in palio dal governo britannico per chi avesse risolto il problema della longitudine.
Ora, nel raccontare questa storia affascinante, Dana Sobel si concentra soprattutto sulle vicende umane… anche con diverse libertà rispetto a ricostruzioni storiche rigorose (per esempio, nel raccontare alle pp. 15-17 il disastro navale delle isole Scilly del 1707 vengono riportate come verità storie di dubbia origine). In fin dei conti, si tratta di un testo divulgativo, non di una sintesi scientifica! E qui le parole sono sufficienti.
 |
L’orologio H-4 di Harrison, a p. 131. |
Anche la parte sui più antichi tentativi astronomici di risolvere il problema mi sembra funzionale. La spiegazione dei ragionamenti di Galileo e di Roemer, per esempio, mi sembra ben comprensibile per molti lettori senza bisogno di immagini (anche se indubbiamente le immagini aiutano).
Il racconto invece diventa meno chiaro quando si inizia a parlare di meccanica, e in particolare degli orologi di Harrison. Qui le indicazioni sono spesso tanto generiche da generare un po’ di frustrazione. Per esempio, a p. 86 si citano due importanti innovazioni di Harrison, il pendolo a griglia e lo scappamento a cavalletta. Solo per la prima, però, viene data una spiegazione minimamente approfondita. Per la seconda viene fornito un testo che spiega l’origine del nome ma che non chiarisce assolutamente niente del modo in cui funzionava il meccanismo:
The grasshopper escapement – the part that counted the heartbeats of the clock’s pacemaker – took its name from the motion of its crisscrossed components. These kicked like the hind legs of a leaping insect, quietly and without the friction that bedeviled existing escapement design (p. 88).
Oppure, il funzionamento del quadrante di Hadley viene descritto in questo modo:
thanks to a trick done with paired mirrors, the new reflecting quadrant allowed direct measurement of the elevation of two celestial bodies, as well as the distances between them. Even if the ship pitched and rolled, the objects in the navigator’s sights retained their relative positions vis-à-vis one another (p. 109).
Tutto bene, ma in che cosa consisteva il trick? Non viene fornita nessuna informazione. Certo, gli autori di un libro possono scegliere il livello di approfondimento che desiderano – ma in questo caso si ha la sensazione che manchi proprio qualcosa di centrale.
E qui entrano in gioco le immagini. Io farei rientrare quelle dell’edizione illustrata in tre tipologie diverse:
- Immagini quasi solo ornamentali (come la statua di Atlante al Rockefeller Center a New York a p. viii)
- Immagini, e sono la maggioranza, che corredano il testo mostrando visivamente protagonisti, luoghi, eventi e oggetti descritti a parole (come il capolavoro di Harrison, l’orologio H-4 del 1759, presentato a dimensioni naturali a p. 131); va aggiunto che le didascalie, realizzate da Andrewes, includono spesso spiegazioni aggiuntive articolate e complesse
- Immagini (inclusi grafici e simili) che, anche in questo caso con l’assistenza delle didascalie, aggiungono al testo informazioni e spiegazioni del tutto assenti nell’originale (come il diagramma presentato a p. 88, che mostra appunto l’aspetto e il funzionamento dello scappamento a cavalletta - anche se nemmeno questa illustrazione riesce a far capire fino in fondo il modo in cui funziona il meccanismo).
La selezione delle immagini è comunque, nel suo complesso, impressionante per estensione e qualità. Di sicuro, il testo che ne viene fuori è molto più completo e più soddisfacente della presentazione fatta solo a parole.
 |
Il diagramma di p. 88 che illustra il funzionamento dello scappamento a cavalletta. |
Tuttavia, a parte alcune immagini schematiche realizzate appositamente, l’apparato iconografico privilegia di gran lunga l’effetto estetico rispetto alla chiarezza. Per esempio, ci sono fotografie che presentano oggetti complessi, ma senza evidenziazioni, indicazioni, frecce che indichino i componenti e così via. Quindi, per esempio, a p. 104 una foto dell’orologio H-2 di Harrison viene accompagnata da una didascalia che dice: “This side view of H-2 shows the remontoire, a device that Harrison designed to provide a more constant source of power to the escapment”. Sì, ma non solo il lettore non viene informato del modo in cui funziona esattamente il remontoire, ma non ha nemmeno modo di capire quale parte del complesso meccanismo in foto è il remontoire. Qualcuno lo può capire da questa foto?
 |
L’orologio H-2 presentato a p. 104. |
Oppure: alla p. 139 si presenta un diagramma d’epoca che descrive il transito di Venere davanti al Sole, ma la didascalia che lo spiega è presentata, per ragioni estetiche, a p. 138, cosa che rende difficile seguire con l’occhio il collegamento tra un elemento del diagramma e la spiegazione – e, soprattutto, le dimensioni della riproduzione sono tali da rendere troppo piccole (almeno per me) le lettere che indicano i punti di riferimento in una parte dello schema.
Insomma, sia il testo sia le immagini si fermano all’inizio di un lungo percorso di spiegazione. In parte la cosa è inevitabile (le questioni trattate sono spesso complesse). Tuttavia, in molti punti sarebbe stato non solo possibile, ma facile, fare diversamente. Un libro divulgativo illustrato può essere più approfondito di così, senza alienare il pubblico cui si rivolge? Io darei una risposta positiva e avrei spinto il punto di equilibrio diversi passi più in là.
Dava Sobel e William J. H. Andrewes, The Illustrated Longitude. The True Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of His Time, New York, Walker and Company, 1998, ISBN 0-8027-1344-0, pp. 216. Comprato usato (copia già delle Josephine Community Libraries di Grants Pass, Oregon.