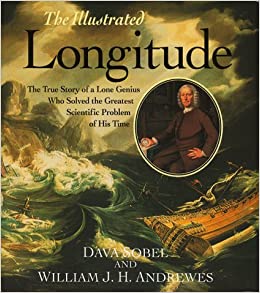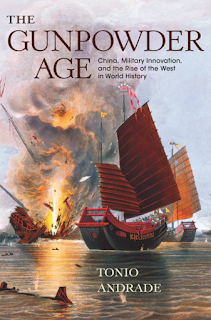Il libro di
Tonio Andrade The Gunpowder Age sembra a prima vista molto lontano dai miei interessi normali: la scrittura, la linguistica italiana, la comunicazione elettronica … In realtà, però, si incrocia con alcuni lavori in corso per diversi aspetti importanti: l’importanza della narrazione nella presentazione di informazioni, il rapporto tra testo e immagine, i rapporti tra
Asia ed
Europa nel Seicento… Per questo motivo ho preso appunti diffusi.
Il libro racconta la diffusione della polvere da sparo confrontando ciò che avvenne in Cina e in Europa durante il periodo in cui questa tecnologia fu importante, dal Medioevo all’Ottocento. Potrebbe sembrare un argomento logoro! Ma la realtà è che questa storia ancora oggi viene spesso raccontata ripetendo luoghi comuni vecchi di secoli e approssimazioni. Rivedere il quadro a mente fresca è importante e permette anche di ripensare situazioni simili.
La scelta degli argomenti e la narrazione
La storia della polvere da sparo viene raccontata da Andrade in ordine cronologico, partendo dalla sua invenzione in Cina. Il racconto descrive poi la diffusione di questa tecnologia in Europa dopo il 1320 e l’arco cronologico si chiude con una specie di rimpatrio: il primo confronto diretto tra gli armamenti cinesi e i loro discendenti europei due secoli più tardi, a partire dal 1511, con l’arrivo dei portoghesi in Oriente. Da qui in poi la trattazione diventa molto più selettiva: non ha più scala globale ma si concentra sulle occasioni di conflitto tra europei e cinesi, mostrando come a un’epoca di conflitti in condizione di “parità” nel Seicento facesse seguito un lungo periodo di pace nel Settecento. Dopodiché, alla riapertura delle ostilità nell’Ottocento, la superiorità occidentale nell’uso degli armamenti era divenuta schiacciante e – fino a oggi – incolmabile.
Dei dettagli di contenuto parlerò più avanti. Diciamo però subito che questa impostazione ha l’enorme vantaggio di permettere un racconto coerente, in ordine sostanzialmente cronologico, al servizio dell’argomentazione dell’autore. I diversi capitoli trattano argomenti molto diversi tra di loro, ma sono ben inseriti in un percorso narrativo compatto che, penso, piacerebbe molto a chi come
Gino Roncaglia insiste molto sull’importanza della complessità nell’
età della frammentazione.
La quarta di copertina del libro riporta un entusiastico giudizio di Jared Diamond, che definisce l’opera “as exciting, dramatic, and engaging as a novel”. Smorzerei un pochino i toni, ma sottoscriverei la sostanza. Anche se una buona revisione potrebbe togliere alcune ripetizioni e alcuni effetti retorici un po’ troppo facili, è vero che la struttura data al libro consente di leggerlo “come un romanzo”.
I contenuti in dettaglio
Come anticipato, il libro parte dalle origini, raccontando ciò che si sa sullo sviluppo, graduale e lento, della polvere da sparo in Cina, incluse le sue applicazioni militari. E qui, i nomi in uso oggi ingannano, suggerendo una continuità che non esiste. Per esempio, poiché le prime formulazioni avevano dei tempi di combustione relativamente lunghi, la polvere da sparo degli esordi veniva di regola usata come semplice sostanza incendiaria, non come esplosivo.
Agli inizi del XII secolo le guerre tra i Song e i Jin portarono però allo sviluppo di armi più efficienti, incluse le famose “lance di fuoco” e le bombe in ferro. Nemmeno queste erano però simili alle armi da fuoco in senso moderno. Le “lance di fuoco”, per esempio, usate da Chen Gui durante l’assedio di De’an nel 1132 (pp. 35-39), erano lance a cui venga agganciato un tubo con polvere da sparo. All’accensione, dal tubo usciva una fiammata che in alcuni casi veniva usata anche per scagliare pietre, con forza ridotta a distanze non tanto grandi (più che vere pallottole, le pietre erano “coviativi”, secondo una definizione di Joseph Needham: p. 51).
Il passo successivo fu quello di usare canne in metallo, in cui potevano essere infilati proiettili di diametro simile a quello dell’apertura. Questa soluzione permetteva di trasferire molta più energia al proiettile, e il meccanismo inizia ad assomigliare alle armi dei secoli successivi. Il primo esemplare databile con sicurezza di un’arma da fuoco in metallo risale al 1298 ed è stato trovato nelle rovine di Xanadu, ma altri reperti potrebbero essere anteriori di alcuni decenni (p. 53). Alla metà del Trecento, i Ming usavano regolarmente armi da fuoco di questo tipo, relativamente piccole e concepite solo per l’uso contro la fanteria.
In parallelo, però, negli anni Venti del Trecento, le armi da fuoco erano già arrivate in
Europa, in forme inizialmente simili a quelle cinesi. La rapidità di questa diffusione, molto superiore a quella di tecnologie come la bussola o la carta, colpisce, così come colpisce il fatto che le altre civiltà asiatiche non vedessero niente di simile. La situazione è sorprendentemente simile a quella della stampa, centocinquant’anni più tardi, e in entrambi i casi rimane la vaga possibilità che quelle europee siano state invenzioni del tutto indipendenti: ma su questi argomenti fa ancora testo
Paper and printing di Tsien Tsuen-Hsuin.
Comunque, non è chiarissimo che aspetto avessero le prime armi da fuoco europee: i primi esemplari conservati risalgono a fine Trecento, le descrizioni a parole (come quella di Petrarca citata da Andrade) sono confuse e i disegni pochi. Apparentemente, erano attrezzi simili a quelli cinesi: “cannoncini” di piccole dimensioni, simili a pentole robuste, oppure armi collocate su pali e simili alle “lance di fuoco”.
In Europa però a questo punto ci fu un’evoluzione rapida, che portò alla nascita di armi di grandi dimensioni: una vera artiglieria, molto diversa da tutto ciò che era stato creato in Cina. A stimolare la trasformazione, secondo Andrade, fu un fattore esterno. Le città e le fortezze cinesi avevano mura di terra, robustissime, e a nessuna persona ragionevole poteva venire in mente di sviluppare armi da fuoco capaci di abbatterle. In Europa però le mura erano sottili… come quelle che a Pisa devo attraversare ogni giorno per andare in Dipartimento. Ciò rendeva concepibile sviluppare armi in grado di abbattere le mura, oltre che uccidere gli esseri umani, e nella ricostruzione di Andrade ciò è appunto quanto accadde a fine Trecento nel ducato di Borgogna (p. 88). Lo sviluppo successivo fu rapido: attorno al 1480 i grossi cannoni europei – e turchi – avevano già preso l’aspetto che conservarono fino all’Ottocento: armi con canne molto lunghe rispetto al diametro della bocca, che sparavano proiettili in ferro (p. 105).
Questi cannoni “classici” (p. 106) si rivelarono efficienti nel fare a pezzi non solo le vecchie fortezze (come in Italia mostrò bene l’arrivo di Enrico VIII) ma anche, imbarcati dai portoghesi, le navi nemiche. I cinesi, nel frattempo, non avevano sviluppato nulla di simile. Per questa divergenza, in aggiunta alla diversa natura delle difese, Andrade propone una spiegazione semplice. La seconda metà del Quattrocento era stata infatti un periodo relativamente pacifico per la Cina (e, aggiungo, per l’Italia), ma non per l’Europa settentrionale. Lì i conflitti avevano dato la spinta giusta al momento giusto.
I frutti della divergenza divennero valutabili nel più concreto dei modi nel giro di pochi decenni: nel 1511 gli europei, e più precisamente i portoghesi, arrivarono per la prima volta in Cina via mare, portandosi dietro appunto i cannoni “classici”. L’accoglienza cinese fu assai più interessata di quanto oggi tipicamente si ritiene: i cannoni europei furono subito individuati come una novità di rilievo, degna di imitazione. Nel 1521, grazie alla propria artiglieria, una piccola flotta portoghese ottenne un’insperata vittoria su una più numerosa flotta cinese nell’estuario del Fiume delle Perle. Già nel 1522, però, i cinesi ottennero una rivincita, anche grazie alle proprie armi da fuoco rapidamente migliorate (pp. 124-131).
Questi episodi introducono la terza parte del libro,
An Age of Parity. Il titolo stesso fa capire che
Andrade condivide un’idea presentata da diversi storici contemporanei, tra cui il
Pomeranz di cui parlavo giusto dieci anni fa. In sostanza, la superiorità europea di questo periodo sarebbe un’illusione ottica creata dal senno di poi: fino al Settecento, le grandi società dell’
Asia si misuravano alla pari con gli europei. E, avendo letto negli ultimi anni un bel po’ di relazioni di viaggio del periodo, anch’io mi sento propenso a concordare.
In ogni caso, i luoghi comuni sul disinteresse dello stato cinese per gli sviluppi tecnologici sembrano, appunto, solo luoghi comuni. L’uso delle fonti cinesi, e in particolare delle storie Ming, mostra che i primi scontri armati produssero un vivo interesse dei letterati verso le novità occidentali. Un alto funzionario confuciano, Wang Hong, per esempio, propose immediatamente di usare i cannoni di modello portoghese per difendere la Grande Muraglia (p. 136). In poco tempo, “The Frankish cannon was, in effect, nativized to China, and (…) the term folangji, or ‘Frankish cannon,’ remained in use, a testament to Confucian bureucrats’ willingness to adopt foreign technologies” (p. 143).
A questo punto inizia uno dei blocchi più consistenti del libro, in cui l’autore lascia da parte l’artiglieria e si dedica alle armi da fuoco individuali. Il capitolo 11 spiega il modo in cui, in fanteria, le armi da fuoco divennero particolarmente efficienti quando fu trovato il modo per impiegarle nel “fuoco di fila”. In altri termini, quando i soldati, invece di sparare tutti assieme con le armi individuali e poi passare un tempo lunghissimo a ricaricare, venivano divisi in file che si davano il cambio, con un gruppo che sparava mentre altri gruppi ricaricavano. Questo evitava lunghe pause nel fuoco e permetteva quindi di tenere a distanza i nemici. In
Europa, la tecnica venne apparentemente sviluppata nel corso del Cinquecento e nel corso della guerra dei Trent’anni contribuì alla fine del predominio dei
tercios spagnoli
di cui ho parlato il mese scorso; ma in
Cina era stata sviluppata già prima della diffusione delle armi da fuoco, per il tiro con balestre, e fu facile adattare il modello all’uso del moschetto moderno.

In ogni caso, nel Seicento cinesi, giapponesi e coreani adottarono entusiasticamente prima l’archibugio e poi il moschetto di tipo europeo (il Giappone poi proibì le armi da fuoco nella lunga pace dei Tokugawa). Per tutto il Seicento, questo produsse una parità militare con gli occidentali, che potevano contare su due soli vantaggi tecnologici privi di equivalenti asiatici: le navi da guerra (capitolo 14) e le fortezze di tipo italiano (capitolo 15), quasi impossibili da attaccare per un nemico impreparato. Gli scontri potevano quindi finire in un modo o nell’altro: se i cinesi si dimostrarono incapaci di tener i russi lontani dai propri confini, riuscirono però a riprendere Taiwan agli olandesi nel 1662.
La parità venne poi persa, gradualmente, nel Settecento. Per quale ragione? Secondo Andrade, di nuovo la più semplice: mentre gli europei continuarono a combattere tra di loro per tutto il secolo, in Cina e in Giappone ci furono lunghissimi periodi di pace. In particolare, durante la lunga pace dei Qing, tra il 1760 e il 1839, gli eserciti cinesi persero per mancanza di allenamento e motivazione quasi tutta la loro capacità bellica: gli esercizi rimanevano puramente formali e le spade arrugginivano nei foderi. Durante la Prima guerra dell’oppio il dislivello divenne quindi evidente in tutta la sua drammaticità: questo è il tema della quarta parte del libro, The Great Military Divergence (che ricollega la questione militare a quella della “grande divergenza” in generale).
Cosa interessante, Andrade attribuisce buona parte della divergenza, già nel Settecento, non solo allo sviluppo sociale e tecnologico ma anche a quello scientifico. In connessione con tutto il resto, certo… ma vale la pena citare qui le conclusioni dell’autore:
I came to believe during the writing of this book that one extra-military factor in particular played a vital role in the Great Military Divergence. I used to teach, in my lectures in Chinese history, that arguments about a lack of Chinese science in the Ming and Qing period were overwrought, that indigenous discourses such as the kaozheng school of evidentiary research were analogous to Western science, and that people have been too quick to discount the many writings on nature within the sea of Chinese thought. Certainly there’s still a tendency to underrate the dynamism of intellectual life in Late Imperial China, but today I find myself agreeing with China specialist Mark Elvin, who writes of his own conversion to the view that “something dramatic” was happening in Europe in the seventeenth century (p. 303).
Qui non posso che concordare anch’io, forse anche per amor di patria: la scienza galileiana non aveva semplicemente equivalenti nel mondo! E dal punto di vista pratico, leggiucchiando in giro, diventa evidente quanto i miglioramenti graduali ma sistematici nelle tecniche delle armi da fuoco e nel modo di adoperarle si accumularono in questo periodo, anche se visivamente l’aspetto esterno delle armi cambiò poco. Il pendolo balistico inventato nella prima metà del Settecento da
Benjamin Robins permise per la prima volta di calcolare con precisione la velocità dei proiettili d’artiglieria e di individuare il ruolo della resistenza dell’aria, portando alla realizzazione di armi molto più pratiche e precise. Da metà Settecento, innovazioni razionali come le
carronate diedero il via a una rincorsa alle prestazioni che oggi può risultare invisibile a chi oggi vede nei cortili dei musei pezzi apparentemente tutti simili gli uni agli altri. Pur cambiando poco all’esterno, i cannoni divennero più maneggevoli, si misero a sparare con più efficienza e si fecero molto più micidiali. Nelle parole di
Andrade:
The British artillerists who fought in the Opium War were able to use ballistics models that took into account the expansion of gas in the gunpowder reaction, the loss of pressure due to the leaking of gas through touchholes and past projectiles, and the effects of wind resistance. The Qing gunners had no such resources (p. 251).
Questo significava, in pratica, che i britannici potevano affondare navi, demolire forti e sterminare la fanteria nemica da lontano e in tutta calma. A Ningbo, un centinaio di inglesi riuscì a respingere un attacco di migliaia di soldati Qing, sterminandoli.
Lo shock della Prima guerra dell’oppio portò, beninteso, a un notevole investimento cinese nell’acquisizione dei sistemi europei: cannoni, navi a vapore, nuove tecniche di addestramento. Alla fine dell’Ottocento, la Cina si era da molti punti di vista più “occidentalizzata” del Giappone. Ma le circostanze erano critiche: dalla prima alla seconda guerra dell’oppio, dalla ribellione dei Tai Ping fino a quella dei Boxer, la storia cinese fu una catena di catastrofi ben oltre l’uscita di scena della polvere da sparo come arma da guerra, sostituita da prodotti più efficienti.
Testo e immagini
Il libro di Andrade include molte immagini al servizio del testo: fotografie, ma anche miniature e disegni d’epoca, europei e cinesi. L’importanza di queste immagini per la chiarezza dell’esposizione è evidente. Le illustrazioni delle pagine 80 e 81, per esempio, mostrano rispettivamente una foto del trecentesco cannone di Loshult e una miniatura quattrocentesca di un’arma da fuoco europea simile alle “lance di fuoco”. Queste riproduzioni fanno capire con assoluta chiarezza quanto le armi da fuoco europee del Medioevo fossero diverse da quelle dei periodi successivi, e dall’immaginario comune. Descrivere le stesse differenze a parole, con la stessa incisività, è davvero difficile!
Inoltre, le immagini stesse sono fonti primarie. Per esempio, parlando del “fuoco di fila”, le semplici testimonianze scritte d’epoca rendono in diverse occasioni impossibile capire se ciò di cui si parla era un vero “fuoco di fila” o no. Viceversa, lo schema di movimento fornito in una lettera di Gugliemo di Nassau a suo cugino Maurizio nel 1594 presenta con chiarezza la tecnica sperimentale descritta nel testo, permettendo di capire che si tratta di un vero “fuoco di fila”. Le immagini che descrivono il comportamento dei balestrieri e moschettieri Ming nel Jun qi tu shuo di Bi Maokang sono altrettanto importanti nel mostrare che la tecnica descritta era un vero “fuoco di fila”. E così via.
Chi poi è interessato ad approfondire questo specifico problema dal punto di vista tecnico può farlo per esempio sulla voce di Wikipedia in lingua inglese dedicata al
fuoco di fila, che si basa quasi per intero appunto su questo libro, riproducendo molte delle immagini chiave (su Wikipedia in lingua italiana non esiste nemmeno una voce dedicata al “fuoco di fila”, e in generale tutte le voci su argomenti simili sono di scarsa qualità).
Il messaggio finale
In sintesi, mi sono sentito in estrema sintonia con l’impostazione di questo libro. Il senno di poi inganna. Le grandi generalizzazioni ingannano. Le storie che tutti conoscono non sempre sono quelle corrette. E dettagli in apparenza secondari possono cambiare completamente l’utilità di una tecnologia o la situazione sociale.
Il senno di poi inganna soprattutto nel Seicento: un’epoca in cui il mondo era già connesso, ma in modo parziale e senza centri di dominio assoluto. Questo è ciò che rende il periodo particolarmente interessante oggi… e, come spero di mostrare nel prossimo futuro, è qualcosa di cui si deve tener conto anche parlando delle lingue in generale, e della lingua italiana in particolare.
Tonio Andrade, The Gunpowder Age. China, Military Innovation, and the Rise of the West in World History, Princeton, Princeton University Press, 2016, ISBN 978-0-691-13597-7, pp. ix + 432. Letto nella copia della Biblioteca di Economia dell’Università di Pisa.