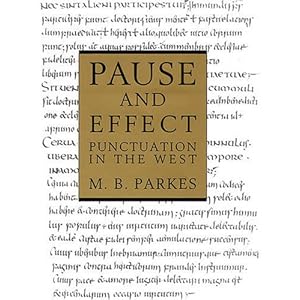Luglio è per me, come lavoro, un mese caldo: correzioni di compiti, tesi di laurea, lavori e progetti da chiudere, ben oltre le otto ore di molti lavori da ufficio... il tutto tenendo come base una stanza in cui l'unica difesa rispetto ai 35° è data da un ventilatorino. Certo, non è come stare tutto il giorno a raccogliere pomodori in un campo in provincia di Latina; ma il punto non è questo. Il punto è che con la manovra finanziaria votata il 15 luglio in Senato, Governo e (, per ora, un ramo del) Parlamento hanno deciso che il "risanamento" dei conti pubblici italiani sarà in buona parte pagato dai dipendenti pubblici. Con particolare attenzione all'università, in cui si congelano gli stipendi per tre anni, senza neanche recupero dell'inflazione - il che equivale a una
diminuzione dello stipendio di docenti e ricercatori universitari stimabile, a seconda di come andrà l'inflazione, in un 6-10% da qui al 2013.
E in risposta, quest'estate aderisco alle proteste.
Questo non significa che l'università italiana, così com'è adesso, sia un'entità perfetta da difendere a ogni costo. Tutt'altro. Però non è neanche del tutto disastrosa: continua a formare laureati di buon livello, ricerca, servizi... Lo fa, apparentemente, in modo
un po' meno efficiente rispetto alle università di altri grandi paesi europei (anche stime come quelle di Roberto Perotti, piuttosto critiche, parlano in realtà di costi per studente superiori del 10% a quelli di altri paesi europei: non si tratta certo di abissi di follia...). Quanto di questa differenza è responsabilità di chi lavora all'università, e quanto del contesto esterno? Difficile da dire. Io ho le mie idee... ma per chiarire il punto cominciamo con le motivazioni della protesta.
Ora, una cosa che molti esterni ignorano: dal punto di vista di chi lavora al suo interno, l'università italiana è egualitaria per certi aspetti, del tutto arbitraria per certi altri. In che senso? A parità di anzianità e di ruolo, lo stipendio è uguale per tutti:
queste sono le tabelle ufficiali dell'Università di Pisa, e il passaggio da un livello di paga al successivo avviene oggi ogni tre anni, mentre fino all'anno scorso avveniva ogni due. Conoscendo ruolo e anzianità di servizio, si può sempre sapere quanto prende (al minimo) un docente.
Le condizioni di lavoro reali, però, sono estremamente diverse. Ci sono università e dipartimenti in cui intere fasce di personale non sono coinvolte nella didattica; e altre in cui le stesse fasce devono lavorare a livelli eccezionali semplicemente per tenere in piedi il corso di laurea cui fanno capo. Oppure, più semplicemente, c'è un'enorme differenza generazionale.
Prendiamo come esempio per quest'ultimo punto due ricercatori: A e B. Non sono persone ben definite, ma rientrano in tipologie ben note a chi lavora all'interno dell'università.
A è entrato in ruolo nel 1982, a meno di trent'anni. Oggi guadagna più o meno sui tremila euro al mese; gentilmente, negli ultimi anni, si è prestato a fare un corso di 30 ore all'anno, e lì si esaurisce il suo impegno didattico. Ogni anno (beh, non tutti-tutti gli anni, ma quasi...) pubblica sulla solita rivista di settore una (una) recensione di una pagina (una) a un libro relativo alla sua disciplina. Ogni tanto segue qualche tesi di laurea, o fa qualche esercitazione. Nel giro di una decina d'anni andrà in pensione, a stipendio praticamente pieno.
B invece è entrato di ruolo da pochi mesi, ma i quarant'anni li ha passati da un pezzo. Oggi, visto che è "in attesa di conferma", prende come stipendio milletrecento euro al mese, e grazie alla legge finanziaria in corso di approvazione rimarrà fermo a questo livello o poco più per quasi sei anni, fino alle soglie della cinquantina. Dopodiché, in mancanza di concorsi e di posti, rimarrà forse ricercatore fino alla pensione - e verso i settant'anni (verso il 2040, incrociando le dita, dovrebbe essere quella l'età del pensionamento) avrà, se va bene, uno stipendio di 2200 euro o giù di lì, destinato a dimezzarsi al momento del pensionamento. Nel frattempo, insegna in due o tre corsi, pubblica, partecipa alle attività amministrative...
Sembrano due mondi diversi, e lo sono. Il primo non è confrontabile con nessuna realtà europea: da nessuna parte si guadagna così tanto, con altrettanta sicurezza, in cambio di così poco. Il secondo è confrontabile come impegni con quelli dei principali paesi europei, ma con una paga decisamente più bassa, e ottenuta a un'età molto più avanzata.
La cosa più carina, però, è un'altra. Uno di questi due ricercatori non rispetta la legge. Ma, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, il trasgressore non è A, è B: i ricercatori italiani hanno limiti precisi a ciò che
possono fare - cioè 350 ore al massimo di attività didattica, incluse lezioni, tesi di laurea, esami, correzioni di compiti... e non c'è dubbio che B superi questo limite.
Folle? Non troppo. In fin dei conti il "ricercatore" era previsto come figura giovane, in formazione - l'equivalente di un dottorando (figura che può insegnare, ma entro limiti rigorosi, perché deve principalmente studiare) o di un assegnista di ricerca. Naturale quindi che dovesse dedicare il proprio tempo allo studio, più che alla didattica. Solo che oggi questa figura giovane non è più tale, anagraficamente e come esperienza. Un po' alla volta, l'università italiana ha cominciato ad appoggiarsi ai ricercatori, che oggi, secondo alcune stime, svolgono un po' meno di un terzo della didattica (essendo circa un terzo del personale docente strutturato). La faccenda poi si fa ancora più complicata... ma per le persone interessate ad approfondire, una storia più articolata della faccenda si ritrova in una
Riflessione sullo stato giuridico dei ricercatori di Fausto Longo.
Insomma, invece di pagare un professore, oggi di regola si paga un ricercatore - che costa decisamente meno, rispetto a un professore associato oppure ordinario con un minimo di anzianità. Chiudendo un occhio di fronte alle indicazioni della legge. Quindi non c'è nemmeno incentivo a trasformare i ricercatori bravi in professori associati oppure ordinari: in fin dei conti, fanno già lo stesso lavoro, ma costano meno...
Dal punto di vista dei ricercatori, non c'è dubbio che questo sia un male. Lo è anche dal punto di vista dell'università in generale, e del contribuente? A prima vista, potrebbe sembrare di no: si ottiene lo stesso servizio pagando meno. Ma in realtà, un posto alle condizioni di A attira molto; un posto alle condizioni di B attira meno. Un motivo non marginale per seguire la carriera universitaria, fino a una quindicina di anni fa, era il fatto che questo settore, pur pagando poco all'inizio, dava notevole libertà e prometteva stipendi discreti a fine carriera. In alcuni settori, il reclutamento del personale universitario è invece oggi un problema - semplicemente, venute a mancare queste condizioni, il dislivello di paga rispetto all'esterno è troppo forte (non stiamo parlando di gente estratta a caso: stiamo parlando di persone, di regola, di capacità notevoli). Nelle facoltà umanistiche il problema è stato sentito relativamente meno, ma negli ultimi anni sta diventando difficile anche qui trovare persone brave interessate a iniziare la carriera accademica. Non sono ancora sparite, per fortuna - ma rispetto a qualche anno fa la differenza (almeno a me) pare evidente.
E quindi? Rendere più gravoso e meno remunerativo il lavoro, superato un certo livello, diventa controproducente: le persone brave, semplicemente, vanno a fare altro (o, se sono già all'interno, incominciano a pensare che invece di fare il B, potrebbero tutto sommato fare l'A... secondo alcuni dati, quasi un terzo dei ricercatori non ha prodotto
nulla dal punto di vista scientifico negli ultimi anni - con, ovviamente, punte massime di inattività tra gli anziani e prepensionandi). Se l'università deve essere solo una fabbrica di pezzi di carta, la cosa non è un problema; se deve essere un'istituzione formativa di buon livello, il problema c'è, eccome.
In questo contesto, l'attuale governo ha già messo limiti agli avanzamenti di carriera e ha ridotto i fondi assegnati all'università; sta ora congelando gli stipendi. Al termine di questo percorso, l'Italia avrà un'università con meno sprechi o un'università con docenti meno bravi e meno motivati? I tagli non tentano nemmeno di distinguere tra chi lavora bene e chi lavora male, e quindi io non ho dubbi sulla risposta. Per questo, appunto, tra un esame e l'altro inizio la protesta.