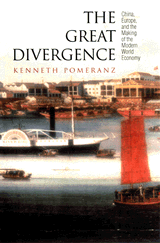 Le osservazioni sul “tipo migliore di educazione” fatte nell’ultimo post portano facilmente a una domanda: esiste davvero un’educazione migliore delle altre? E se sì, come facciamo a riconoscerla?
Le osservazioni sul “tipo migliore di educazione” fatte nell’ultimo post portano facilmente a una domanda: esiste davvero un’educazione migliore delle altre? E se sì, come facciamo a riconoscerla?Alla seconda domanda viene naturale rispondere che la bontà dell’educazione dovrebbe essere giudicabile in base ai suoi effetti. Basta un attimo, però, per capire che le cose non sono così semplici. Le persone di maggior successo non sono sempre quelle che hanno ricevuto un’educazione migliore, e viceversa – e, tanto per dirne una, la diversità dei punti di partenza (sociali e familiari) complica molto l’analisi. In Italia, come più o meno in tutto il resto del mondo, i laurati guadagnano più dei diplomati e molto di più rispetto a chi ha solo la licenza media, ma questa differenza è frutto dell’istruzione o di processi di selezione sociale? E qual è la parte che può essere attribuita, a livello individuale, all’educazione?
Gli studi sociologici tentano di routine di identificare le variabili di situazioni del genere e di isolarne le cause. Si può però tentare anche di inquadrare il problema nel suo assieme e di vedere le cose a livello di intere società. Le società con il miglior sistema di educazione dovrebbero cavarsela meglio delle altre. In retrospettiva, quindi, vedere le società (per esempio, le nazioni) che hanno avuto più successo dovrebbe essere un ottimo metodo per individuare il miglior sistema di educazione.
Anche in questo caso, però, le cose non sono così facili.
In passato ho già citato le conclusioni di Landes sulla prosperità delle nazioni. In sintesi: non c’è una ricetta evidente per il successo. Le “spiegazioni” oggi fornite da storici e studiosi per il successo di una società o dell’altra sono diverse fra loro, in parte contraddittorie e comunque tutt’altro che sicure.
Valutazioni del genere valgono anche per le cause dell’evento più vistoso dell’ultimo millennio: il predominio mondiale delle società europee (o delle loro dirette emanazioni). Dalla fine del Medioevo a oggi le società europee hanno dominato gran parte del pianeta e, negli ultimi due secoli, sono diventate enormemente più ricche e potenti di aree con cui fino a quel momento si erano misurate alla pari, a cominciare dalla Cina e dall’India. Nell’Ottocento hanno instaurato il proprio dominio ovunque, e per buona dparte nel Novecento l’unica società non-europea che è riuscita a competere con loro sullo stesso piano è stata il Giappone. Perché questa divergenza?
Le risposte oggi corrente sono tutt’altro che sicure. A volte sono collegate all’educazione, a volte no. Chi legge Il ruggito della mamma tigre ha l’impressione che il “modello educativo cinese” sia destinato a produrre risultati incomparabili e individui di capacità eccezionali. Eppure, ammettendo per ipotesi che le cose stiano così, la società nel suo assieme non sembra in grado di tirar fuori molto di utile da questo modello educativo: la Cina, per quanto sia da trent’anni in grande espansione economica, ha da secoli un reddito pro capite che è solo una frazione di quello europeo (al momento, è al livello di quello egiziano), e da secoli ha solo un ruolo periferico nella produzione scientifica e in quella artistica. Se la sua espansione durerà per altri trent’anni, a metà del Ventunesimo secolo arriverà ad avere un PIL superiore a quello degli Stati Uniti, ma con una popolazione quattro volte superiore... e quindi con un reddito pro capite ancora pari a un quarto di quello USA. Eppure a inizio Ottocento l’economia cinese era forse pari a quella di Stati Uniti ed Europa messi assieme.
Come mai quindi, negli ultimi due secoli l’Europa si è distinta così nettamente da aree che le erano equivalenti o superiori? The great divergence di Kenneth Pomeranz (Princeton, Princeton University Press, 2000) affronta questo argomento fin dal titolo. E il suo primo capitolo si apre con una constantazione: “There is no consensus on how Europe became uniquely wealthy by the mid-nineteenth century” (p. 33). Anche per quanto riguarda l’educazione (e, più in generale, la cultura), il peso assegnato a questo elemento varia da un minimo a un massimo.
The great divergence si schiera comunque con decisione sul lato del “peso minimo” – anzi, nullo. Nella sua ricerca di spiegazioni della divergenza, il libro discute in modo critico un numero impressionante di fattori: dati demografici, calorie consumate dalla popolazione, sicurezza della proprietà... i titoli di alcune delle Appendici (pp. 301-338) dànno, credo, un’idea precisa di questa varietà:
- Stime comparative della capacità di trasporto terrestre per individuo: Germania e India settentrionale attorno al 1800
- Stima delle quantità di letame usate nelle fattorie della Cina settentrionale e in quelle europee alla fine del Settecento, con un confronto dei corrispondenti flussi di azoto
- Stime sul potere d’acquisto dei lavoratori tessili rurali nella regione cinese del Basso Yangzi tra il 1750 e il 1840
Tutta la seconda parte del libro è quindi dedicata a illustrare le somiglianze tra Europa, India, Cina e Giappone, almeno per i punti che possono influenzare direttamente lo sviluppo economico. La preferenza è data poi ai fattori misurabili e oggettivabili. Non quindi, per esempio, all’astratto “individualismo” o “collettivismo” delle società, ma alla frequenza delle espropriazioni e alle garanzie sui beni individuali; non allo “spirito d’iniziativa” dei mercanti, ma ai tassi d’interesse praticati sui vari mercati. Eccetera. L’idea di base sembra quindi solida: andare a cercare non tracce di alcuni “oggetti” alquanto vaghi e nebulosi (lo “spirito del capitalismo”?), ma delle loro conseguenze.
Dopodiché, presi in esame i fattori culturali, Pomeranz dichiara esplicitamente che “Most of these [= culturali e istituzionali] arguments (…) fail to decisively differentiate wester Europe’s prospects from those of China and Japan, though they may well separate these three from the rest of the world. (India is a complex intermediate case.)” (pp. 112-113). Basandosi su dati più recenti di quelli di Landes, gli europei del Settecento non sembrano di per sé migliori mercanti o artigiani rispetto a cinesi e giapponesi; i mercati non erano più liberi in Europa che in Cina (semmai, il contrario); i tassi d’interesse erano forse più bassi in Europa, ma con un differenziale che non sembra determinante, e così via.
La conclusione di Pomeranz è quindi che la Rivoluzione industriale non sia stata l’esito inevitabile di differenze sociali e culturali. Piuttosto, è stata l’effetto di fattori di per sé non tipicamente europei in un contesto in cui – per puro caso – la Gran Bretagna aveva facile accesso a risorse che in un momento cruciale le hanno permesso di aggirare i limiti ecologici del proprio territorio: grandi giacimenti di carbone vicino ai centri manifatturieri, e le risorse del Nuovo Mondo a portata di mano.
La parte propositiva delle tesi di Pomeranz è però la più debole. Come hanno notato diversi osservatori, nell’economia britannica del Settecento il rapporto con il Nuovo Mondo aveva per esempio un ruolo marginale: al massimo il 7% del totale, secondo i calcoli dello stesso Pomeranz. Possibile che uno scarto tanto piccolo basti a giiustificare la rivoluzione epocale che ne è seguita?













Nessun commento:
Posta un commento