domenica 31 luglio 2011
Recensione di Giuseppe Antonelli all'Italiano del web
giovedì 28 luglio 2011
Le conseguenze inattese della tecnologia

Gli studi di storia economica forniscono molte lezioni interessanti sui rapporti tra cultura e tecnologia; dai due libri che ho citato nelle ultime settimane (Pomeranz e Clark) mi sembra giusto estrarre almeno un’ultima indicazione: le conseguenze inattese di una tecnologia sul tenore di vita.
Una cosa su cui gli studi moderni concordano, in effetti, è che le più significative innovazioni culturali degli ultimi millenni non hanno migliorato, fino a pochi secoli fa, il tenore di vita – e hanno molto peggiorato il modo in cui gli esseri umani, in media, vivono. L’agricoltura, innanzitutto: come nota soprattutto Clark, gli agricoltori tradizionali lavoravano molto di più dei cacciatori-raccoglitori. In molte culture e in molti periodi si superano le dieci ore al giorno, perdipiù con attività pesanti e svolte in condizioni di alimentazione insufficiente. Al confronto, gli attuali cacciatori-raccoglitori devono “lavorare” qualcosa come cinque-sei ore al giorno (anche se ovviamente moltissimo dipende dall’ambiente in cui vivono); e tra gli animali più vicini a noi alcune specie di scimmie impiegano nelle attività indispensabili quattro ore al giorno o giù di lì.
(tra parentesi, ammetto che finora, a differenza degli economisti, non mi ero mai chiesto quale fosse l’orario medio di lavoro delle varie razze di scimmie... ma l’orario medio di lavoro dei felini è chiaramente ancora più ridotto...)
Inoltre, come già detto, le condizioni materiali di vita degli agricoltori pre-industriali non sembra fossero affatto migliori di quelle dei cacciatori-raccoglitori, nonostante ciò che per secoli è stato scritto sull’argomento. Adam Smith fin dalle prime pagine dlla Ricchezza delle nazioni metteva “the savage nations of hunters and fishers” a contrasto con le “civilized and thriving nations” concludendo che in queste ultime
a workman, even of the lowest and poorest order, if he is frugal and industrious, may enjoy a greater share of the necessaries and conveniencies of life than it is possible for any savage to acquire (Introduction)
In realtà invece sembra che la situazione fosse ben diversa, e che perfino nelle parti più ricche d’Europa la media della popolazione avesse standard di vita più bassi (come speranza media di vita, calorie consumate, tempo a disposizione, varietà della dieta e via dicendo) rispetto alle popolazioni di cacciatori-raccoglitori che è possibile studiare oggi, e a ciò che i dati archeologici ci dicono sulle popolazioni del passato. Conseguentemente, fino all’Ottocento, i gruppi di europei che entravano in contatto con i “selvaggi” si trovavano a perdere spesso gente per strada: persone che, a cominciare dagli ammutinati del Bounty, evidentemente ritenevano che il professor Smith non avesse poi tutta quella gran ragione, e che a prendere la strada della foresta loro personalmente avessero molto da guadagnare e poco da perdere.
Oggi, naturalmente, il fascino della vita selvaggia sembra assai più ridotto di un tempo. Una curiosa testimonianza di prima mano è quella di Lawrence Osborne, che nel Turista nudo ha raccontato pochi anni fa delle sue (non idilliache) esperienze in Nuova Guinea e in particolare del terrificante livello di violenza che generalmente si incontra in queste società – in alcuni degli studi usati da Clark come base per il suo lavoro, l’omicidio risulta la prima causa di morte tra i cacciatori-raccoglitori. Però, anche se non al punto di indurre a mollare tutto, un po’ di fascino persiste. I racconti di Daniel Everett sono particolarmente da questo punto di vista, con il contrasto tra la visione a-religiosa e rilassata dei pirahã amazzonici e l’enorme diversità del tenore di vita (in un punto particolarmente spiazzante, Everett racconta di amici pirahã che, ricevendo foto e lettere da parte di un vecchio missionario che li aveva visitati decenni prima, chiedono perplessi: “ma gli americani non muoiono mai?”).
Resta però il fatto che, come fa notare Clark, i progressi medici oggi consentono la sopravvivenza di grandi masse di popolazione a tenore di vita bassissimo – al punto che oggi vivono, come viene dichiarato nelle prime pagine del suo libro, sia le persone più ricche che siano mai esistite, sia le più povere. In sostanza, quindi, l’avvento dell’agricoltura ha peggiorato, fino a tempi recentissimi, il modo in cui in media gli esseri umani vivevano – ma ha permesso l’esplosione della popolazione, e ha fatto sì che, in sostanza, le società agricole arrivassero a sostituire i cacciatori-raccoglitori in quasi tutto il mondo. Fino al punto in cui, dopo millenni di lavoro nei campi, non è arrivata la civiltà industriale a permettere un balzo in avanti senza precedenti... Quello che negli ultimi decenni è possibile vedere negli affascinanti grafici animati di Gapminder.
Lezione fondamentale da queste meditazioni a largo raggio: affrontare i problemi del rapporto tra cultura e tecnologia richiede una grande umiltà intellettuale. Per questo motivo, ultimamente, quando sento dire che “i computer” o “l’educazione” sono la soluzione per tutto, o la causa di tutti i problemi, sbuffo un po’. Raramente i problemi complessi hanno soluzioni semplici.
martedì 26 luglio 2011
Clark, A Farewell to Alms
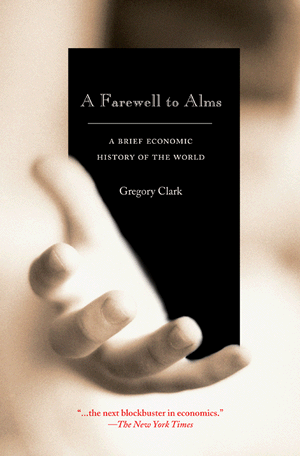 Il modo in cui Pomeranz vede il rapporto tra cultura e progresso sociale è solo uno tra i tanti. Al polo opposto, per molti versi, si collocano le tesi di Gregory Clark esposte in A Farewell to Alms (Princeton University Press, Princeton, 2007). In questo volume, infatti, le cause della Rivoluzione industriale non sono identificate nella vicinanza di giacimenti di carbone o nella disponibilità di risorse coloniali, ma nella diffusione di abitudini. Il tutto in un contesto in cui
Il modo in cui Pomeranz vede il rapporto tra cultura e progresso sociale è solo uno tra i tanti. Al polo opposto, per molti versi, si collocano le tesi di Gregory Clark esposte in A Farewell to Alms (Princeton University Press, Princeton, 2007). In questo volume, infatti, le cause della Rivoluzione industriale non sono identificate nella vicinanza di giacimenti di carbone o nella disponibilità di risorse coloniali, ma nella diffusione di abitudini. Il tutto in un contesto in cui in the long run economic institutions, psychology, culture, politics and sociology are deeply intervowen. Our very nature – our desires, our aspirations, our interactions – was shaped by past economic institutions, and it now in turn shapes modern economic systems (loc. 104-105 su Kindle).
Un passo indietro, per dare un po’ di contesto. Clark parte da un’idea forte: la Rivoluzione industriale è stata un evento senza precedenti nella storia anche perché ha significato, per una porzione sempre crescente dell’umanità, la fine del ciclo malthusiano. In passato, per gli uomini come per qualunque specie animale, un aumento di risorse produceva un aumento della popolazione, il che portava a un calo graduale delle risorse pro capite, il che portava a un aumento della mortalità, fino al punto in cui l’equilibrio si ristabiliva. I progressi tecnici stabili (a cominciare dall’introduzione dell’agricoltura) non potevano quindi migliorare il tenore di vita medio della popolazione, ma permettevano semplicemente l’esistenza di una popolazione più numerosa rispetto a prima.
Poi è arrivata la Rivoluzione industriale, con la sua crescita economica non controbilanciata da un aumento equivalente della popolazione, e la gente ha iniziato a vivere meglio. Non è diventata per questo più felice (come nota Clark nelle pagine finali, i moderni studi di psicologia concordano nel ritenere che la felicità sia una cosa relativa... uno “stare meglio degli altri”, in modo quasi indipendente dallo stile medio di vita); però fatica molto meno e vive molto più a lungo.
Su questo siamo d’accordo. Ma quali sono le cause della Rivoluzione industriale? Clark ha studiato la storia dell’economia inglese tra il 1200 e il 1870, ed è convinto che la risposta non stia in qualche accidente geografico, ma stia nel modo particolare in cui la società inglese rispondeva alle pressioni malthusiane. In primo luogo, rispetto a civiltà paragonabili, come per esempio quella giapponese, gli inglesi del Settecento si trovavano ad essere più ricchi perché per ragioni culturali avevano uno standard igienico più basso e morivano quindi più giovani. In secondo luogo, a differenza dei ricchi giapponesi, i ricchi inglesi (nobiltà e borghesia) facevano più figli dei poveri: fino al doppio, in media, secondo la ricostruzione di Clark. In una situazione economica statica, questa prolificità faceva sì che i figli dei ricchi scendessero lungo la scala sociale e gradualmente arrivassero a sostituire la discendenza dei poveri, diffondendo così in ogni strato sociale i valori con cui erano stati formati.
Difficile dire quanto questa ricostruzione sia corretta. Un punto chiave per giudicare il suo valore, naturalmente, sta nella misura della ricchezza: gli inglesi del Settecento erano davvero più ricchi dei loro coetanei cinesi e giapponesi? Come detto nell’ultimo post, Pomeranz ritiene di no, ma Clark si schiera esplicitamente contro la ricostruzione del collega e pensa invece che la differenza fosse sensibile, come richiesto dalla teoria malthusiana: a sostanziale parità tecnologica, maggiore densità di popolazione = minor reddito medio, e già all’epoca i paesi dell’Estremo oriente erano popolati più densamente dei paesi europei. Alle dettagliate analisi di Pomeranz, peraltro, Clark contrappone solo le descrizioni dei viaggiatori del periodo. Non è molto, ma è vero che il senso comune dei contemporanei può essere un indicatore più preciso di molti calcoli degli economisti moderni (qui come altrove, semplicemente, le informazioni che abbiamo sono insufficienti a consentire certezze).
In sostanza, quindi, secondo Clark la Rivoluzione industriale è stata solo un fenomeno culturale, prodotto per caso: una società in cui le virtù “borghesi” sono diventate tanto diffuse da permettere un progresso così rapido da consentire l’uscita dalla trappola malthusiana.
Ahimè, Clark lascia molto nel vago i dettagli di questo quadro, inclusi molti punti chiave (e non si vede come avrebbe potuto essere altrimenti, in un libro piuttosto breve). Non è un difetto da poco, ma le idee stimolanti possono anche non essere perfette, all’inizio... Però, dopo articolata discussione di dettagli, Clark chiude il libro in fretta con una spiegazione molto molto semplificata di quello che dovrebbe essere il punto chiave. Perché l’Europa? Perché nessun altro, fino a pochi anni fa? La risposta è molto sintetica: produttività individuale, generata dalle virtù di cui sopra. Agli inizi del Novecento, con macchine tessili identiche, un operaio americano produceva tanto tessuto quanto otto indiani; e così via.
Certo, la produttività è senz’altro una parte della risposta... ma è anche evidente che sulle cause effettive della differenza di produttività Clark rimane molto sul vago, e che non bastano due o tre numeri per spiegare un fenomeno vasto, complesso e articolato. Soprattutto se si tiene conto del fatto che, chiaramente, la diffusione “demografica” di comportamenti virtuosi è tutt’altro che sufficiente a spiegare i successi economici di molti paesi tra Otto e Novecento, oppure oggi.
Resta il fatto che, nonostante i suoi difetti, il libro è molto stimolante. E contribuisce a far pensare che, insomma, non sia tutta questione di accidenti della geografia, ma che le cose che le persone imparano a scuola abbiano un peso non irrilevante nel modo in cui poi va il mondo.
sabato 16 luglio 2011
Pomeranz, The great divergence
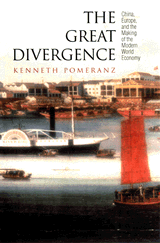 Le osservazioni sul “tipo migliore di educazione” fatte nell’ultimo post portano facilmente a una domanda: esiste davvero un’educazione migliore delle altre? E se sì, come facciamo a riconoscerla?
Le osservazioni sul “tipo migliore di educazione” fatte nell’ultimo post portano facilmente a una domanda: esiste davvero un’educazione migliore delle altre? E se sì, come facciamo a riconoscerla?Alla seconda domanda viene naturale rispondere che la bontà dell’educazione dovrebbe essere giudicabile in base ai suoi effetti. Basta un attimo, però, per capire che le cose non sono così semplici. Le persone di maggior successo non sono sempre quelle che hanno ricevuto un’educazione migliore, e viceversa – e, tanto per dirne una, la diversità dei punti di partenza (sociali e familiari) complica molto l’analisi. In Italia, come più o meno in tutto il resto del mondo, i laurati guadagnano più dei diplomati e molto di più rispetto a chi ha solo la licenza media, ma questa differenza è frutto dell’istruzione o di processi di selezione sociale? E qual è la parte che può essere attribuita, a livello individuale, all’educazione?
Gli studi sociologici tentano di routine di identificare le variabili di situazioni del genere e di isolarne le cause. Si può però tentare anche di inquadrare il problema nel suo assieme e di vedere le cose a livello di intere società. Le società con il miglior sistema di educazione dovrebbero cavarsela meglio delle altre. In retrospettiva, quindi, vedere le società (per esempio, le nazioni) che hanno avuto più successo dovrebbe essere un ottimo metodo per individuare il miglior sistema di educazione.
Anche in questo caso, però, le cose non sono così facili.
In passato ho già citato le conclusioni di Landes sulla prosperità delle nazioni. In sintesi: non c’è una ricetta evidente per il successo. Le “spiegazioni” oggi fornite da storici e studiosi per il successo di una società o dell’altra sono diverse fra loro, in parte contraddittorie e comunque tutt’altro che sicure.
Valutazioni del genere valgono anche per le cause dell’evento più vistoso dell’ultimo millennio: il predominio mondiale delle società europee (o delle loro dirette emanazioni). Dalla fine del Medioevo a oggi le società europee hanno dominato gran parte del pianeta e, negli ultimi due secoli, sono diventate enormemente più ricche e potenti di aree con cui fino a quel momento si erano misurate alla pari, a cominciare dalla Cina e dall’India. Nell’Ottocento hanno instaurato il proprio dominio ovunque, e per buona dparte nel Novecento l’unica società non-europea che è riuscita a competere con loro sullo stesso piano è stata il Giappone. Perché questa divergenza?
Le risposte oggi corrente sono tutt’altro che sicure. A volte sono collegate all’educazione, a volte no. Chi legge Il ruggito della mamma tigre ha l’impressione che il “modello educativo cinese” sia destinato a produrre risultati incomparabili e individui di capacità eccezionali. Eppure, ammettendo per ipotesi che le cose stiano così, la società nel suo assieme non sembra in grado di tirar fuori molto di utile da questo modello educativo: la Cina, per quanto sia da trent’anni in grande espansione economica, ha da secoli un reddito pro capite che è solo una frazione di quello europeo (al momento, è al livello di quello egiziano), e da secoli ha solo un ruolo periferico nella produzione scientifica e in quella artistica. Se la sua espansione durerà per altri trent’anni, a metà del Ventunesimo secolo arriverà ad avere un PIL superiore a quello degli Stati Uniti, ma con una popolazione quattro volte superiore... e quindi con un reddito pro capite ancora pari a un quarto di quello USA. Eppure a inizio Ottocento l’economia cinese era forse pari a quella di Stati Uniti ed Europa messi assieme.
Come mai quindi, negli ultimi due secoli l’Europa si è distinta così nettamente da aree che le erano equivalenti o superiori? The great divergence di Kenneth Pomeranz (Princeton, Princeton University Press, 2000) affronta questo argomento fin dal titolo. E il suo primo capitolo si apre con una constantazione: “There is no consensus on how Europe became uniquely wealthy by the mid-nineteenth century” (p. 33). Anche per quanto riguarda l’educazione (e, più in generale, la cultura), il peso assegnato a questo elemento varia da un minimo a un massimo.
The great divergence si schiera comunque con decisione sul lato del “peso minimo” – anzi, nullo. Nella sua ricerca di spiegazioni della divergenza, il libro discute in modo critico un numero impressionante di fattori: dati demografici, calorie consumate dalla popolazione, sicurezza della proprietà... i titoli di alcune delle Appendici (pp. 301-338) dànno, credo, un’idea precisa di questa varietà:
- Stime comparative della capacità di trasporto terrestre per individuo: Germania e India settentrionale attorno al 1800
- Stima delle quantità di letame usate nelle fattorie della Cina settentrionale e in quelle europee alla fine del Settecento, con un confronto dei corrispondenti flussi di azoto
- Stime sul potere d’acquisto dei lavoratori tessili rurali nella regione cinese del Basso Yangzi tra il 1750 e il 1840
Tutta la seconda parte del libro è quindi dedicata a illustrare le somiglianze tra Europa, India, Cina e Giappone, almeno per i punti che possono influenzare direttamente lo sviluppo economico. La preferenza è data poi ai fattori misurabili e oggettivabili. Non quindi, per esempio, all’astratto “individualismo” o “collettivismo” delle società, ma alla frequenza delle espropriazioni e alle garanzie sui beni individuali; non allo “spirito d’iniziativa” dei mercanti, ma ai tassi d’interesse praticati sui vari mercati. Eccetera. L’idea di base sembra quindi solida: andare a cercare non tracce di alcuni “oggetti” alquanto vaghi e nebulosi (lo “spirito del capitalismo”?), ma delle loro conseguenze.
Dopodiché, presi in esame i fattori culturali, Pomeranz dichiara esplicitamente che “Most of these [= culturali e istituzionali] arguments (…) fail to decisively differentiate wester Europe’s prospects from those of China and Japan, though they may well separate these three from the rest of the world. (India is a complex intermediate case.)” (pp. 112-113). Basandosi su dati più recenti di quelli di Landes, gli europei del Settecento non sembrano di per sé migliori mercanti o artigiani rispetto a cinesi e giapponesi; i mercati non erano più liberi in Europa che in Cina (semmai, il contrario); i tassi d’interesse erano forse più bassi in Europa, ma con un differenziale che non sembra determinante, e così via.
La conclusione di Pomeranz è quindi che la Rivoluzione industriale non sia stata l’esito inevitabile di differenze sociali e culturali. Piuttosto, è stata l’effetto di fattori di per sé non tipicamente europei in un contesto in cui – per puro caso – la Gran Bretagna aveva facile accesso a risorse che in un momento cruciale le hanno permesso di aggirare i limiti ecologici del proprio territorio: grandi giacimenti di carbone vicino ai centri manifatturieri, e le risorse del Nuovo Mondo a portata di mano.
La parte propositiva delle tesi di Pomeranz è però la più debole. Come hanno notato diversi osservatori, nell’economia britannica del Settecento il rapporto con il Nuovo Mondo aveva per esempio un ruolo marginale: al massimo il 7% del totale, secondo i calcoli dello stesso Pomeranz. Possibile che uno scarto tanto piccolo basti a giiustificare la rivoluzione epocale che ne è seguita?













