lunedì 20 dicembre 2010
Studiare l'esperienza degli e-book
Sul Domenicale del Sole-24 ore della settimana scorsa, all'interno di una sezione dedicata agli e-book, Roberto Casati apre un articolo: "Non mi risultano dati scientifici che comparino l'esperienza di leggere un e-book a quella di leggere un libro su carta" (a p. 22). I dati, però, ci sono e possono essere considerati ormai assestati.
Naturalmente, il modo in cui Casati parla della lettura è molto generico. Che cosa si intende per "comparino l'esperienza"? Per esempio, potremmo intendere una descrizione delle diversità di comportamento. E qui le cose cambiano molto da un tipo di testo all'altro. I romanzi - beh, si leggono su Kindle e iPad esattamente come su carta: una pagina alla volta, dall'inizio alla fine.
Diversa è la situazione per i libri di studio. Per esempio, Jenny Lau ha sintetizzato in questo modo la bibliografia recente in un articolo intitolato Students’ experience of using electronic textbooks in different levels of education (Scroll, 1, 1, 2008):
Learning behaviour changes when one accesses text in electronic format. Students are accustomed to scan through the text to get an overview of the material. This, however, becomes difficult while using an electronic version (Waycott & Kukulska-Hulme, 2003). Instead of scanning through the text, students may skim it. When reading electronic text, students prefer to start from the table of contents to determine which chapters seem relevant (Hernoon, Hopper, Leach, Saunders, & Zhang, 2007). Highlighting, underlining, and note taking, activities that are considered to support active reading, are not equally represented in digital form. For instance, medical students found that taking notes in electronic format was not as natural as with paper (Morton, Foreman, Goede, Bezzant, & Albertine, 2007) (p. 5).
Oppure, potremmo decidere di rispondere a Casati su questo punto cercando di capire non tanto se le esperienze sono diverse quanto se il gradimento è diverso. Lau ritrova in bibliografia una maggiore accettazione (ovvia) dei testi elettronici da parte delle generazioni più giovani. Se dalle preferenze relative si passa a quelle assolute, però, le cose cambiano, come risulta da uno studio originale di William Douglas Woody, David B. Daniel e Crystal A. Baker, E-books or textbooks: Students prefer textbooks, pubblicato su Computers & Education, 55 , 2010, pp. 945–948 (purtroppo, accessibile solo a pagamento o da reti abbonate). L'abstract dice già tutto:
Previous research has demonstrated that the experience of reading e-books is not equivalent to reading textbooks. This study examines factors influencing preference for e-books as well as reported use of e-book content. Although the present student cohort is the most technologically savvy to ever enter universities, students do not prefer e-books over textbooks regardless of their gender, computer use or comfort with computers. No significant correlations existed between the number of e-books previously used and overall preference of e-books: Participants who had previously used an e-book still preferred print texts for learning. Despite the ability to easily access supplemental content through books via hyperlinks and other features, students were more likely to use special features in print books than in e-books.
In sostanza, potendo scegliere, gli studenti preferiscono studiare su libri su carta. E, poiché reagiscono in questo modo anche studenti che hanno già usato e-book, la causa probabile di questa preferenza non è l'abitudine ma la semplice usabilità. Gli addetti ai lavori lo sanno, ma ci vorrà un po' di tempo prima che queste osservazioni diventino di dominio comune...
Naturalmente, il modo in cui Casati parla della lettura è molto generico. Che cosa si intende per "comparino l'esperienza"? Per esempio, potremmo intendere una descrizione delle diversità di comportamento. E qui le cose cambiano molto da un tipo di testo all'altro. I romanzi - beh, si leggono su Kindle e iPad esattamente come su carta: una pagina alla volta, dall'inizio alla fine.
Diversa è la situazione per i libri di studio. Per esempio, Jenny Lau ha sintetizzato in questo modo la bibliografia recente in un articolo intitolato Students’ experience of using electronic textbooks in different levels of education (Scroll, 1, 1, 2008):
Learning behaviour changes when one accesses text in electronic format. Students are accustomed to scan through the text to get an overview of the material. This, however, becomes difficult while using an electronic version (Waycott & Kukulska-Hulme, 2003). Instead of scanning through the text, students may skim it. When reading electronic text, students prefer to start from the table of contents to determine which chapters seem relevant (Hernoon, Hopper, Leach, Saunders, & Zhang, 2007). Highlighting, underlining, and note taking, activities that are considered to support active reading, are not equally represented in digital form. For instance, medical students found that taking notes in electronic format was not as natural as with paper (Morton, Foreman, Goede, Bezzant, & Albertine, 2007) (p. 5).
Oppure, potremmo decidere di rispondere a Casati su questo punto cercando di capire non tanto se le esperienze sono diverse quanto se il gradimento è diverso. Lau ritrova in bibliografia una maggiore accettazione (ovvia) dei testi elettronici da parte delle generazioni più giovani. Se dalle preferenze relative si passa a quelle assolute, però, le cose cambiano, come risulta da uno studio originale di William Douglas Woody, David B. Daniel e Crystal A. Baker, E-books or textbooks: Students prefer textbooks, pubblicato su Computers & Education, 55 , 2010, pp. 945–948 (purtroppo, accessibile solo a pagamento o da reti abbonate). L'abstract dice già tutto:
Previous research has demonstrated that the experience of reading e-books is not equivalent to reading textbooks. This study examines factors influencing preference for e-books as well as reported use of e-book content. Although the present student cohort is the most technologically savvy to ever enter universities, students do not prefer e-books over textbooks regardless of their gender, computer use or comfort with computers. No significant correlations existed between the number of e-books previously used and overall preference of e-books: Participants who had previously used an e-book still preferred print texts for learning. Despite the ability to easily access supplemental content through books via hyperlinks and other features, students were more likely to use special features in print books than in e-books.
In sostanza, potendo scegliere, gli studenti preferiscono studiare su libri su carta. E, poiché reagiscono in questo modo anche studenti che hanno già usato e-book, la causa probabile di questa preferenza non è l'abitudine ma la semplice usabilità. Gli addetti ai lavori lo sanno, ma ci vorrà un po' di tempo prima che queste osservazioni diventino di dominio comune...
martedì 14 dicembre 2010
Kamkwamba, The boy who harnessed the wind
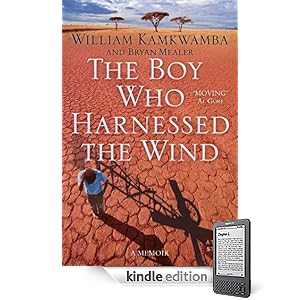 Domanda: è possibile imparare qualcosa solo leggendo? Sì, chiaramente; ma fino a quale punto?
Domanda: è possibile imparare qualcosa solo leggendo? Sì, chiaramente; ma fino a quale punto?The boy who harnessed the wind, raccontato direttamente dal ragazzo del titolo (William Kamkwamba, in collaborazione con Bryan Mealer), è anche una risposta a questa domanda. Il libro, infatti, è la storia di come pochi anni fa un ragazzo del Malawi si sia in testa, in un villaggio quasi del tutto privo di corrente elettrica, di realizzare un generatore a vento per portare la luce in casa. Senza avere a disposizione incoraggiamenti o insegnanti, ma solo una biblioteca con qualche scaffale di libri in inglese arrivati per donazione.
Un libro in particolare, Explaining physics (sembrerebbe questo), gioca un ruolo fondamentale, perché fornisce le indicazioni necessarie: a capire i principi alla base della dinamo, o la differenza tra corrente continua e corrente alternata, o il modo per cambiare la tensione. Non che il protagonista non abbia già qualche base, dall'inglese all'algebra (imparati in scuole con i buchi nel pavimento, senza libri né attrezzature); però in un contesto in cui nessuno, dalla famiglia ai pochi proprietari di biciclette e luci elettriche, ha la minima idea di come funzioni la corrente.
Il libro, insomma, è la storia di un successo. Con una storia che però prende forma solo a metà del testo, perché le prime sezioni raccontano la vita di William Kamkwamba, la storia della sua famiglia e, soprattutto, la carestia del 2001, che (assieme alla vendita, fatta poco prima, delle riserve nazionali di grano, e alla sparizione dei profitti risultanti...) porta alla fame l'intero villaggio e il resto del paese. Dopodiché, nel giro di qualche anno, abbandonata la scuola, il protagonista si trova quasi per caso a creare il suo mulino a vento. Dopo il successo, la radio e i giornali locali lo notano, e da lì a una conferenza TED il passo - beh, non è breve, ma è rapido:
Il racconto è avvincente. Soprattutto, però, fa ricordare che i libri permettono a volte di fare cose sorprendenti, quando incontrano un lettore preparato a prenderli sul serio.
mercoledì 8 dicembre 2010
Presentazione di Eisner, 9 dicembre

Will Eisner (1917-2005) è stato uno dei più importanti autori di fumetti del Novecento. Oggi è celebrato soprattutto per il suo stile personale e per i suoi personaggi di grande successo, a cominciare da Spirit, oltre che per essere stato il creatore della graphic novel moderna. In aggiunta alla sua attività di soggettista e disegnatore, però, Eisner è stato anche un insegnante e un importante teorico del fumetto. A partire dagli anni Ottanta ha quindi realizzato manuali che sono allo stesso tempo riflessioni d’artista su questo mezzo di comunicazione e, grazie a un’imponente quantità di esempi grafici e di tavole di grandi autori, vere e proprie gallerie di immagini.
Come già raccontato questo blog, Fabio Gadducci e il sottoscritto hanno tradotto i due manuali più famosi di Eisner (Comics and Sequential Art e Graphic Storytelling and Visual Narrative), pubblicati quest'anno da Rizzoli in un volume unico con il titolo L'Arte del Fumetto. Giovedì 9 dicembre presenteremo il lavoro al Museo della Grafica di Pisa (Palazzo Lanfranchi) alle 17.30.
giovedì 2 dicembre 2010
Smolderen, Naissances de la bande dessinée
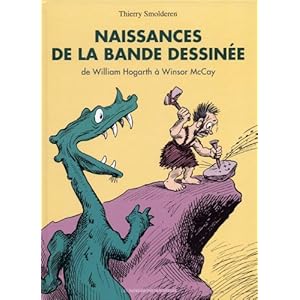
Nel dibattito sulla nascita del fumetto, il recente Naissances de la bande dessinée di Thierry Smolderen (Les impressions nouvelles, s. l., 2009) è un contributo non perfetto ma molto importante.
Come mai, "non perfetto"? Semplicemente perché Smolderen dedica molta attenzione a definizioni e cose marginali, o sbagliate. Il libro ha il sottotitolo "de William Hogarth à Winsor McCay", e, appunto, essendo il punto di partenza, l'opera di Hogarth è una delle cose su cui Smolderen si concentra di più. Tuttavia la sua argomentazione è strana: Hogarth è importante non perché le sue incisioni siano fumetti (non lo sono), quanto perché le sue opere sono costruite per essere decifrate (sono "diagrammatiques") e combinano elementi di tradizioni grafiche diverse in un modo che ricorda la polifonia bachtiniana del romanzo dell'epoca. Entrambi questi aspetti diventeranno importanti nel secolo successivo, e saranno alla base del protofumetto dell'Ottocento. In Hogarth convivono, secondo Smolderen, in questo modo:
"Cherchez le diagramme!" est le mot d'ordre, la règle du jeu. Quel que soit son parcours dans l'image, l'oeil découvre à chaque lecture de noveaux rapports, de nouvelles articulations ironiques. Car c'est là que réside toute la modernité d'Hogarth: sa vision polémique de la société anglaise s'exprime par diagramme interposé, en faisant jouer toutes les couches du langage graphique de son temps. La mise en oeuvre de cette "poliphonie" graphique est ce qui le rapproche des inventeurs du roman moderne comme Henry Fielding et Laurence Sterne, qui confrontaient pareillement dans leurs oeuvres toutes les veines, tous les registres du langage parlé et écrit de l'époque (p. 15).
Gli aspetti che non tornano in questa ricostruzione sono evidenti. Innanzitutto, la "decifrabilità" delle opere è una costante delle arte grafiche, non un'invenzione di Hogarth! E la "polifonia", sarà davvero passata da Hogarth ad autori come Doré e Grandville? Può anche darsi; ma in realtà Hogarth non mi sembra molto "polifonico"; in alcuni casi viene chiaramente imitato dai disegnatori successivi, ma dimostrare che sia lui alla base di tutto... beh, ci vorrebbe come minimo un altro libro!
Osservazioni discutibili si trovano poi anche in altri punti del libro. Anzi, è curioso, almeno per me, vedere come Smolderen oscilli spesso tra analisi convincenti (per esempio quando mostra la netta opposizione formale tra il Little Jack e il Little Nemo di McCay) e altre... meno. Ma la sensazione finale non è affatto quella di un libro che non funziona. Al di là dei (numerosi) punti che non convincono, l'autore ha senz'altro centrato il problema principale. In una risposta agli storici del fumetto che nella produzione grafica dell'Ottocento cercano solo embrioni del fumetto moderno, Smolderen ricostruisce un contesto complesso. Individua infatti tutta una serie di "antenati" della narrazione grafica a cui ben pochi hanno pensato in precedenza: dai repertori di espressioni facciali al servizio degli attori fino alle prime sequenze fotografiche create per ricostruire le fasi dei movimenti veloci.
Su questi punti inoltre Smolderen, più che raccontare, mostra: il corredo iconografico del libro è semplicemente fantastico, e sembra tutto frutto di ricerche di prima mano. La copertina non rende giustizia a questa incredibile galleria di immagini, mai viste in giro e spesso molto belle.
Dal mio punto di vista, poi, uno degli aspetti più interessanti (anche se marginali in questa trattazione) è il modo in cui molti autori dell'Ottocento legano il lavoro sulla stilizzazione delle immagini a una riflessione teorica. Alla ricerca, com'è naturale, di una "grammatica" dei gesti e delle espressioni. Gli esempi tratti da Cruikshank e Grandville, alle pp. 36 e 37, sono i più affascinanti, ma non gli unici, e fanno il paio con i molti tentativi dell'epoca di codificare e "scrivere" tante cose che, a differenza del linguaggio, si sono rivelate poi molto refrattarie alla schematizzazione. Tuttavia, anche se il tentativo più di tanto non può spingersi, vedere il modo in cui alcune personalità geniali cercano di affrontare il problema è senz'altro molto istruttivo!
sabato 27 novembre 2010
Meccanica delle ore perse

Che cosa si fa quando gli studenti occupano e bloccano le lezioni? Domanda interessante, soprattutto quando i loro obiettivi (= fermare il percorso parlamentare del DDL sull'università) sono perfettamente ragionevoli e, per quel che mi riguarda, condivisi.
Dunque, protestare va benissimo. Salire sui tetti va bene... l'ho fatto anch'io (foto n. 8, in posa un po' improbabile). I cortei vanno bene. Le dichiarazioni di indisponibilità dei ricercatori non solo vanno bene, ma in molti casi cancellano una situazione di illegalità (visto che molti di noi, me compreso, dedicano a lezioni, esami e tesi più tempo di quanto permesso dalla legge, e fanno quindi una cosa che non si dovrebbe fare...).
Viceversa, bloccare traffico, treni e aerei non va bene, e basta. D'accordo, in Italia lo fanno tutti: da chi protesta per le multe delle quote latte fino ai tifosi. Però questo non rende meno odiose le prepotenze di questo tipo - neanche se fatte in nome di obiettivi meritevoli.
E bloccare le lezioni? Anche questo non va bene, ma per un breve periodo è tollerabile, e forse non ha troppi effetti. Certo, la pretesa di minoranze minuscole (di regola, partecipa attivamente alle proteste non più di un 5% di studenti) di parlare a nome di tutti è ridicola. E la pratica di impedire le lezioni bloccando le aule è, semplicemente, un atto di prepotenza.
Detto questo... Un pacco postale arriva o non arriva. Un treno è in orario o è in ritardo. Ma un corso universitario che funziona non è necessariamente un corso in cui tutte le ore sono svolte: il corso funziona se gli studenti imparano, punto. Le ore di lezione, da questo punto di vista, sono solo uno strumento al servizio di un risultato.
E quindi, le ore perse sono un problema? La sorpresa (ma non tanto, per gli addetti ai lavori) è che è molto difficile dirlo. Per l'Università di Pisa, attualmente, un credito corrisponde a 7 ore di lezione. Due anni fa corrispondeva a 6 ore: i corsi da 12 crediti sono passati quindi da 72 a 84 ore. Ciò significa che le conoscenze degli studenti sono aumentate del 15%? Difficile capirlo, ma, verosimilmente, no. Di sicuro, i programmi di molti corsi sembrano rimasti uguali, e il monte ore complessivo di impegno richiesto agli studenti non è variato.
In sostanza, l'insegnamento dà struttura allo studio, ma non sembra esista una proporzione diretta tra il tempo passato in aula e l'apprendimento. Come fa notare anche Luca Serianni, forse nella scuola italiana le ore di lezione sono / erano troppe. Anche nell'Università di Pisa la discussione sul numero di ore di lezione necessario per raggiungere un credito si muove tra le 5 (caldeggiate da molti docenti di Lettere e Filosofia) e le 8 (richieste, sembra, da molti docenti di facoltà scientifiche). Il tutto, ovviamente, a parità di risultati attesi, e in mancanza di dati solidi che dimostrino la maggiore efficacia di una soluzione o dell'altra.
Insomma, supponendo che la banda di oscillazione 5-8 corrisponda alla realtà, in un semestre con 10 o 11 settimane perfino tre o quattro settimane di blocco della didattica potrebbero non avere effetti pratici sull'insegnamento di molte materie. Questo non vuol dire che l'occupazione (non unanime) sia una forma di protesta accettabile: non si può imporre agli altri la propria volontà, se non nelle forme definite dalle leggi. Vuol dire però che questo sgarbo, a differenza di molti altri, forse non produce conseguenze di rilievo - e, paradossalmente, potrebbe addirittura portare a un apprendimento più efficace (!)... se, per esempio, i sostenitori delle 5 ore avessero ragione.
martedì 16 novembre 2010
Black & Decker

Una delle differenze fondamentali tra testi elettronici e testi su carta, comunque, è: la carta occupa spazio. E così, dopo anni di rinvii, finalmente ho comprato assi e viti e ho messo assieme una libreria per il garage. Il tutto, in sostanza, per contenere un bel po' di numeri di Topolino e Urania che altrimenti sarebbero rimasti nelle casse dell'ultimo trasloco. Non è una cosa sana... anche perché il valore di mercato del contenente, probabilmente, non è molto superiore al costo del legname necessario per contenerlo.
Però, tant'è... Una fila di titoli ben allineati è sempre una soddisfazione.
Prossimo passo - e lavoro per una delle prossime sere: riordinare la raccolta dei Pdf sul computer. Sarà più rapido, ma, temo, molto meno divertente.
mercoledì 3 novembre 2010
Serianni, L'ora di italiano
Tra un appuntamento e l'altro, oggi ho letto L'ora di italiano: scuola e materie umanistiche di Luca Serianni (usc
 ito a luglio da Laterza, ristampato a ottobre, comprato al volo stamattina in Feltrinelli al prezzo di nove euro).
ito a luglio da Laterza, ristampato a ottobre, comprato al volo stamattina in Feltrinelli al prezzo di nove euro).Di solito sono un po' diffidente verso i libretti-pamphlet di questo genere. Poco più di cento pagine, piccolo formato, caratteri grandi: il contenuto è di regola qualcosa che starebbe in venti o trenta pagine di rivista, e spesso è in qualche modo riciclato. Il nome di Serianni però è una garanzia, e anche se qui si vede una certa fretta di produzione, le circostanze in cui è stato realizzato il lavoro sono tali da dare un rilievo particolare al testo. Serianni infatti è stato consulente per l'ultima riforma dei programmi di liceo, e le sue opinioni hanno quindi avuto la possibilità di pesare in modo inconsueto.
All'interno del libro c'è, in un paio di punti (p. 40 e pp. 50-51), l'elogio del riassunto come strumento didattico. Del tutto in linea con questa impostazione, provo quindi a sintetizzare alcuni dei discorsi più interessanti - con l'avviso che, essendo questo un riassunto-per-linguisti, lascio fuori le considerazioni più generali (e, di regola, unanimamente condivise dagli addetti ai lavori) per concentrarmi solo su quelle che, in qualche misura, sono un po' più specifiche, e spesso più soggettive:
- la competenza linguistica, a differenza di quella letteraria, si presta a essere misurata anche con domande "chiuse", ed è quindi facile da verificare (p. ix)
- in un quadro di modeste prestazioni degli studenti italiani, "colpisce la scarsa padronanza del lessico astratto (...) e la regressione del lessico meno usuale" (p. x)
- per l'insegnante, è importante "soprattutto" un requisito psicologico: "credere al lavoro che fa e scommettere su sé stesso" (p. xii)
- primo capitolo: considerazioni di buon senso sulle diversità tra cultura umanistica e cultura scientifica
- secondo capitolo: necessità della compresenza di "Scienze e lettere nella scuola"
- la riforma Gelmini "va indubbiamente verso un riequilibrio tra discipline umanistiche e scientifico-tecnologice, reso ancora più evidente dalla complessiva riduzione del monte ore: una riduzione dipendente dalla scelta o dalla necessità di economizzare - impossibile negarlo -, ma sostenibile anche col principio pedagogico di ridurre le ore di presenza degli alunni a scuola, repingendo la correlazione più ore = più profitto scolastico" (pp. 19-20)
- inevitabile potenziare l'inglese, ma "lascia perplessi la norma di prevedere fin d'ora nell'ultimo anno l'uso della lingua straniera per una disciplina non linguistica": sia perché i docenti non sono preparati, sia perché questo potrebbe comportare l'abbandono della capacità di trasmettere alcune materie scientifiche in italiano, e non è pensabile che in settori del genere " lingua rinunci a una e di sovranità (...) appaltandola a una lingua straniera" (pp. 20-21)
- comunque, ci sono riserve sull'aumento di alunni per classe (p. 21)
- ormai c'è "marginalizzazione del liceo classico rispetto al liceo scientifico, che rappresenta ormai la scelta non marcata per (...) una preparazione generalista per poi continuare gli studi universitari"; come esito, il classico si è femminilizzato e meridionalizzato (p. 22)
- il latino si è indebolito (e perde ore, nei programmi post-riforma) per queste ragioni e per una serie di fattori aggiuntivi, tra cui la riduzione di prestigio (p. 23)
- in realtà, al di là dei molti discorsi pro e contro, il latino è importante per il "suo significato storico", e in alcune scuole è bene mantere "il contatto diretto con i testi originali" (p. 28)
- d'altra parte, il peso della versione classica dovrebbe essere ridimensionato nella didattica del latino (pp. 29-36)
- il docente d'italiano nella secondaria inferiore e superiore deve fare diverse cose contemporaneamente: "insegnare la lingua, prima di tutto", stimolare l'interesse per la lettura, avviare alla conoscenza dei classici, alimentare discussioni su temi di attualità (p. 37)
- più che chiedere opinioni su temi difficili da inquadrare bene, i docenti dovrebbero sviluppare nei discenti "i meccanismi dell'argomentazione" (p. 38)
- esempio di "una lezione sul barocco che valorizzi il rapporto con la pittura coeva", prendendo spunto da Mattia Preti - esempio, devo dire, ben poco credibile, in base alla mia esperienza della didattica liceale! (pp. 41-42)
- importanza del rigore nella valutazione (pp. 42-44), anche perché i problemi di lingua impediscono il successo in pratica in qualunque altra materia (p. 44)
- nella scuola dell'obbligo tutti devono essere portati a determinati obiettivi, ma nelle fasce successive occorre discriminare il valore e non cancellare la responsabilità dei singoli (p. 45)
- esempi di esercizi divertenti (beh, più o meno...) per i vari livelli di scuola (pp. 46-50), e di verifiche di comprensione del testo a livello avanzato (pp. 51-52)
- i problemi del tema e quelli delle prove alternative (pp. 53-60)
- sesto capitolo: i problemi delle grammatiche contemporanee, con qualche suggerimento per intervenire sui punti critici (pp. 61-75)
- settimo capitolo: il problema dell'arricchimento lessicale, con progetto di far arrivare tutti i diciottenni scolarizzati al livello di competenza necessario a "capire pienamente l'editoriale di uno dei grandi quotidiani" (p. 77)
- ottavo capitolo: spunti didattici sulla letteratura a scuola, con osservazioni su come alcuni fenomeni linguistici in Dante possano essere illustrati solo in un corso universitario, altri nello studio liceale, e altri ancora debbano essere proposti all'attenzione di tutti (p. 91)
- nono capitolo: insegnamento dei classici, e mantenimento della lettura dei testi più antichi in lingua originale
domenica 31 ottobre 2010
Tesi e tempi di lettura
Oggi c'è la tendenza a considerare le prove finali della laurea triennale come "poco significative". Beh, certo non sono le vecchie tesi di laurea quadriennali, che a Lettere spesso significavano un minimo di duecento pagine di testo e un annetto di lavoro: a Informatica umanistica a Pisa è previsto che l'"elaborato di laurea" sia lungo trenta-trentacinque pagine, e che lavoro e stesura non portino via più di due mesi.
Nella mia esperienza, però, anche dagli elaborati di laurea possono venir fuori molte cose interessanti. Trenta pagine sono l'equivalente di un articolo di discrete dimensioni, o di un capitolo di libro; se le tesi poi sono molte, gli argomenti possono essere integrati e il lavoro reso più complesso.
Nella pratica, molte delle tesi che ho assegnato in questi anni, in aggiunta al loro valore didattico, si sono rivelate interessantissime anche a livello di contenuti. Una buona parte dei dati nuovi inclusi nel mio prossimo libro sull'italiano del web deriva da questi lavori (oltre che da quelli prodotti dagli studenti dei corsi, e dalle mie ricerche individuali). Adesso invece è arrivato il turno delle indagini sui tempi di lettura, e i primi risultati sono molto interessanti.
Quali sono i termini della questione? In realtà, il punto di partenza sono le mie esperienze di lettore. Da un paio d'anni ho cominciato a leggere testi lunghi su iPhone. Decenni di studi di usabilità dicono che la lettura su schermo è più lenta di quella su carta; su iPhone, però, la differenza mi pareva tanto ridotta che mi è sembrato opportuno fare delle verifiche. Le più importanti misurazioni dei tempi di lettura risalgono infatti agli anni Ottanta, quando la tecnologia degli schermi era quella che era, e i fosfori verdi erano un vertice di usabilità. I progressi recenti, in fatto di schermi, sono notevolissimi... ma ben pochi ricercatori, apparentemente, hanno sentito il bisogno di controllare se le nuove tecnologie hanno qualche effetto sui tempi di lettura. Né finora erano state fatte prove con testi in italiano.
Adesso stanno arrivando i primi risultati delle ricerche che seguo, e le impressioni sembrano confermate: sullo schermo di un moderno notebook, o di un iPad, i lettori procedono quasi con la stessa velocità con cui procedono sulla carta stampata. Rispetto ai rallentamenti del 20-25% segnati finora, siamo al 3%. È troppo presto per considerare definitivi dei risultati del genere - ma le tesi procedono, e può darsi che presto diventi necessario cambiare in diversi punti i manuali di scrittura!
Nella mia esperienza, però, anche dagli elaborati di laurea possono venir fuori molte cose interessanti. Trenta pagine sono l'equivalente di un articolo di discrete dimensioni, o di un capitolo di libro; se le tesi poi sono molte, gli argomenti possono essere integrati e il lavoro reso più complesso.
Nella pratica, molte delle tesi che ho assegnato in questi anni, in aggiunta al loro valore didattico, si sono rivelate interessantissime anche a livello di contenuti. Una buona parte dei dati nuovi inclusi nel mio prossimo libro sull'italiano del web deriva da questi lavori (oltre che da quelli prodotti dagli studenti dei corsi, e dalle mie ricerche individuali). Adesso invece è arrivato il turno delle indagini sui tempi di lettura, e i primi risultati sono molto interessanti.
Quali sono i termini della questione? In realtà, il punto di partenza sono le mie esperienze di lettore. Da un paio d'anni ho cominciato a leggere testi lunghi su iPhone. Decenni di studi di usabilità dicono che la lettura su schermo è più lenta di quella su carta; su iPhone, però, la differenza mi pareva tanto ridotta che mi è sembrato opportuno fare delle verifiche. Le più importanti misurazioni dei tempi di lettura risalgono infatti agli anni Ottanta, quando la tecnologia degli schermi era quella che era, e i fosfori verdi erano un vertice di usabilità. I progressi recenti, in fatto di schermi, sono notevolissimi... ma ben pochi ricercatori, apparentemente, hanno sentito il bisogno di controllare se le nuove tecnologie hanno qualche effetto sui tempi di lettura. Né finora erano state fatte prove con testi in italiano.
Adesso stanno arrivando i primi risultati delle ricerche che seguo, e le impressioni sembrano confermate: sullo schermo di un moderno notebook, o di un iPad, i lettori procedono quasi con la stessa velocità con cui procedono sulla carta stampata. Rispetto ai rallentamenti del 20-25% segnati finora, siamo al 3%. È troppo presto per considerare definitivi dei risultati del genere - ma le tesi procedono, e può darsi che presto diventi necessario cambiare in diversi punti i manuali di scrittura!
venerdì 22 ottobre 2010
Noir de noir

Ho appena ricevuto Noir de noir. Un'indagine pluridisciplinare, pubblicato da Peter Lang (Bruxelles, etc., 2010) a cura di Dieter Vermandere, Monica Jansen e Inge Lanslots. Il volume contiene i contributi presentati al convegno di Anversa del 2006, e all'interno ci sono due articoli miei:
- La Versilia di Giampaolo Simi. Ricostruzione del parlato, lessico locale e rielaborazioni editoriali, pp. 217-224
- con Fabio Gadducci, L'emersione del noir. Spunti dalla produzione di una casa editrice bolognese, pp. 239-245.
Peccato però che il testo non sia disponibile in formato elettronico: ormai mi sono abituato a linkare e distribuire i contenuti in questo modo. Anzi, direi che per gli articoli scientifici ho passato da un po' il confine tra il momento in cui la sorpresa è data dalla presenza del testo elettronico e quello in cui la sorpresa è data invece dalla sua assenza.
martedì 19 ottobre 2010
Forza sette?

Da ieri a oggi ho fatto un po' di ordine negli appunti e ho ritirato fuori alcuni appunti che si erano accumulati.
Primo fra tutti, per cominciare con lo spirito giusto, un servizio pubblicato su Wired a fine settembre. Il servizio si intitola 7 Essential Skills You Didn't Learn in College e, con la tipica retorica di Wired, vorrebbe presentare un curriculum universitario
che colma le lacune della vostra educazione da ventesimo secolo con gli attrezzi di cui avete bisogno adesso. Chiamiamole "arti neoliberali": istruzione superiore per umani altamente evoluti.
Dal mio punto di vista, è un curriculum molto lusinghiero. Di queste sette "arti neoliberali" per esseri superiori, ben due sono già coperte dai miei corsi: Writing for New Forms (cioè, "autoespressione in 140 caratteri") era parte del Laboratorio di scrittura degli ultimi anni, mentre la Remix Culture ("campionature, remix e mescolanze") era al centro del corso sul Linguaggio del web che ho tenuto nella primavera del 2010.
Dov'è l'inghippo, quindi? Semplicemente, nel fatto che argomenti di questo genere non sono, in realtà, centrali per un'educazione. La scrittura per "i nuovi generi" ha senso se inserita all'interno di una trattazione più generale della scrittura. Altrimenti, imparare i trucchetti per scrivere su Twitter non richiede più di un paio d'ore (e non porta molto lontano). Allo stesso modo, il remix è un argomento interessante, ma entro certi limiti. Si vive, si studia e si lavora benissimo anche con quel poco di pratica di "remix" che si può assorbire dall'ambiente, senza bisogno di una formazione dedicata.
Naturalmente, pochi prendono sul serio la retorica di Wired. Però, se si volesse farlo, sarebbe interessante notare che anche le altre cinque "arti" proposte non sono poi così rilevanti. O meglio, solo una, la prima, "Alfabetizzazione statistica", lo è senz'altro - e dovrebbe come tale essere inserita in tutti i programmi di scuola superiore, a differenza di aree della matematica (per esempio, che so, la trigonometria) che hanno un buon valore formativo ma di cui ben pochi hanno bisogno nella vita di tutti i giorni. La statistica sì: a occhio, dopo le quattro operazioni e la capacità di lavorare con i numeri frazionari, è il ramo della matematica più immediatamente applicabile per, beh, per tutti, letterati compresi.
E le altre materie? Non ho le competenze per parlarne nel dettaglio, ma direi che sono probabilmente, più che materie, scelte di vita, oppure, all'estremo opposto della scala, aree ristrette su cui specializzarsi. Magari, quando si è già terminato un buon corso che metta in grado di contestualizzare per benino anche temi periferici.
lunedì 18 ottobre 2010
Consegnato!
Stasera ho finalmente spedito all'editore il mio libro sull'italiano del web. Certo, non è un lavoro finito al cento per cento, perché manca ancora l'introduzione, e la bibliografia va sistemata... ma insomma, è andata! Se va tutto bene, il libro sarà fuori per la primavera.
lunedì 27 settembre 2010
Prossimi convegni
In questi ultimi giorni di scrittura parteciperò anche a due convegni. In entrambi i casi parlerò di argomenti collegati all'italiano del web.
Al convegno della Società di linguistica italiana (SLI) a Viterbo presenterò mercoledì 29, assieme a Elisa Bianchi e Margherita Castelli, una Analisi dei fenomeni di contatto tra inglese e italiano nella piattaforma MOODLE e nei forum di Html.it.
Al congresso della Società internazionale di linguistica e filologia italiana (SILFI) a Napoli presenterò martedì 5 ottobre un intervento sulle Mescolanze di lingua nei social network professionali, e in particolare su LinkedIn.
Il grosso del lavoro, perlatro, in questi giorni continua ad andare alla revisione del libro sull'italiano del web. Ultima volata, spero...
Al convegno della Società di linguistica italiana (SLI) a Viterbo presenterò mercoledì 29, assieme a Elisa Bianchi e Margherita Castelli, una Analisi dei fenomeni di contatto tra inglese e italiano nella piattaforma MOODLE e nei forum di Html.it.
Al congresso della Società internazionale di linguistica e filologia italiana (SILFI) a Napoli presenterò martedì 5 ottobre un intervento sulle Mescolanze di lingua nei social network professionali, e in particolare su LinkedIn.
Il grosso del lavoro, perlatro, in questi giorni continua ad andare alla revisione del libro sull'italiano del web. Ultima volata, spero...
domenica 12 settembre 2010
Lavori in corso
Non è che sono sparito: è che sto chiudendo il mio libro sull'italiano del web (consegna prevista al 25 settembre), e naturalmente gli ultimi giorni sono una corsa... Spero comunque di inserire presto il prossimo post.
martedì 17 agosto 2010
Carr, The shallows
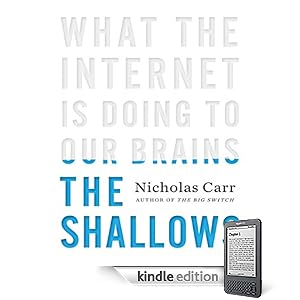
La tesi di base di Nicholas Carr in The Shallows è che Internet rende le persone meno intelligenti. Tesi ben argomentata (nei limiti in cui può esserlo una cosa del genere, visto lo stato attuale delle conoscenze), e in molti punti convincente. Tesi perfino vera, forse, per quanto riguarda i singoli individui. Tesi probabilmente sbagliata per quanto riguarda l'assieme della società.
Cosa interessante, Carr si basa molto, per la ricostruzione storica, di due libri di cui ho parlato a lungo anch'io: Space between words di Paul Saenger e Proust and the squid di Maryanne Wolf. Il secondo, perché buona parte di The shallows è dedicata a spiegare l'ovvio: che il cervello di chi legge è più abituato a, ahem, leggere... e che, svolgendo spesso la stessa attività, diventiamo più bravi a farla.
Una cosa che però mi sorprende molto, in libri di questo genere, è la mancanza di riferimenti alle pressioni esterne. Se davvero Internet rende più superficiali, non dovrebbe esserci grande richiesta di persone che non sono state rovinate in questo modo? Se la nostra memoria se ne va perché la esternalizziamo, quanto dovremo pagare, per esempio, i piloti d'aereo? O i chirurghi? O, in genere, chiunque abbia bisogno di memorizzare un po' di informazioni complesse per portare a compimento il proprio lavoro.
giovedì 5 agosto 2010
Copia e remix
A Dipartimento chiuso, un po' di bilanci. Il Laboratorio di scrittura di quest'anno è stato, come al solito, interessante: gli studenti hanno prodotto molte voci di Wikipedia di buon livello, su argomenti su cui, di regola, ho parecchio da imparare.
Certo, ogni tanto qualcuno presenta voci che sembrano copiate direttamente da qualche fonte scritta. Niente di troppo allarmante, però: direi che siamo in linea con l'esperienza che ho avuto nel settore negli ultimi dieci anni. In fin dei conti, gli studenti italiani (ma non solo) arrivano spesso all'Università senza che nessuno abbia mai detto loro come funzionano le cose nella scrittura scientifica e professionale. Per citare solo i punti più importanti:
Certo, un assaggio così superficiale forse non rende ragione della complessità delle tesi esposte, ma alcune delle cose contenute nel libro mi sembrano proprio sbagliate. Che, come si dice a p. 6, gli studenti abbiano adesso un "nuovo modo" per concepire i testi e i loro autori mi sembra, semplicemente, falso. I problemi del capire chi ha scritto che cosa, e come citarlo, sono identici a quelli su cui battevo il naso io ai tempi delle ricerchine della scuola media, in tempi beatamente ignoranti di computer e remix. Il modo "giusto" per fornire informazioni non è qualcosa che si conosce intuitivamente e poi si scorda quando si comincia a lavorare con Photoshop: è una prassi convenzionale che di solito si impara attraverso un insegnamento esplicito - diciamo, attraverso corsi come il mio... E, giustamente, l'articolo del Times si conclude indicando che, nei casi reali, dietro alle scopiazzature nei lavori non sembra si trovi un "nuovo modo" di concepire i testi: si trova il fatto che gli studenti vogliono passare gli esami in fretta e con voti alti (sapendo benissimo che copiare non va bene).
Insomma, come dice una commentatrice, Sarah Wilensky, remix o non remix, "If you’re taught how to closely read sources and synthesize them into your own original argument in middle and high school, you’re not going to be tempted to plagiarize in college, and you certainly won’t do so unknowingly". In Italia, per di più, di questo genere d'insegnamento c'è ben poca traccia, quindi io non mi lamento poi troppo se mi trovo a ripetere decine di volte, come ho fatto nelle ultime settimane, che un conto è prendere informazioni, un conto copiare, eccetera eccetera. Qualcuno deve pur farlo!
Certo, ogni tanto qualcuno presenta voci che sembrano copiate direttamente da qualche fonte scritta. Niente di troppo allarmante, però: direi che siamo in linea con l'esperienza che ho avuto nel settore negli ultimi dieci anni. In fin dei conti, gli studenti italiani (ma non solo) arrivano spesso all'Università senza che nessuno abbia mai detto loro come funzionano le cose nella scrittura scientifica e professionale. Per citare solo i punti più importanti:
- le informazioni non vengono dall'aria: o sono informazioni di prima mano , oppure si deve indicare da dove si sono state riprese
- le informazioni si possono riprendere, indicando opportunamente la fonte, ma le parole esatte no (a meno che non si tratti di citazione letterale, opportunamente indicate)
- quando si scrive qualcosa, bisogna sapere che cosa significa ciò che si sta scrivendo: copiare parole e frasi prese da qualche fonte non serve a molto.
Certo, un assaggio così superficiale forse non rende ragione della complessità delle tesi esposte, ma alcune delle cose contenute nel libro mi sembrano proprio sbagliate. Che, come si dice a p. 6, gli studenti abbiano adesso un "nuovo modo" per concepire i testi e i loro autori mi sembra, semplicemente, falso. I problemi del capire chi ha scritto che cosa, e come citarlo, sono identici a quelli su cui battevo il naso io ai tempi delle ricerchine della scuola media, in tempi beatamente ignoranti di computer e remix. Il modo "giusto" per fornire informazioni non è qualcosa che si conosce intuitivamente e poi si scorda quando si comincia a lavorare con Photoshop: è una prassi convenzionale che di solito si impara attraverso un insegnamento esplicito - diciamo, attraverso corsi come il mio... E, giustamente, l'articolo del Times si conclude indicando che, nei casi reali, dietro alle scopiazzature nei lavori non sembra si trovi un "nuovo modo" di concepire i testi: si trova il fatto che gli studenti vogliono passare gli esami in fretta e con voti alti (sapendo benissimo che copiare non va bene).
Insomma, come dice una commentatrice, Sarah Wilensky, remix o non remix, "If you’re taught how to closely read sources and synthesize them into your own original argument in middle and high school, you’re not going to be tempted to plagiarize in college, and you certainly won’t do so unknowingly". In Italia, per di più, di questo genere d'insegnamento c'è ben poca traccia, quindi io non mi lamento poi troppo se mi trovo a ripetere decine di volte, come ho fatto nelle ultime settimane, che un conto è prendere informazioni, un conto copiare, eccetera eccetera. Qualcuno deve pur farlo!
lunedì 26 luglio 2010
Parkes, Pause and effect
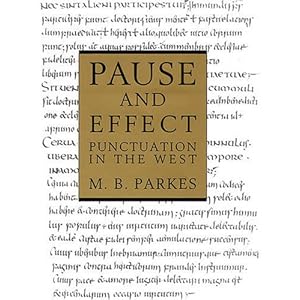
Un altro libro fondamentale per lo studio della punteggiatura: Pause and effect di Parkes. Ne avevo già parlato in un post di giugno per la qualità delle immagini. Andando a leggerlo in dettaglio, le impressioni positive sono confermate.
E però...
E però, da questi libri non si riesce a tirar fuori una cosa: una schematizzazione chiara e dettagliata di che cosa è stata la punteggiatura per le varie epoche. Vale per questo, vale per Space between words (per le sezioni pertinenti), vale per la Storia della punteggiatura in Europa. Ogni tanto si incontra un livello di dettaglio superiore, ma di solito ci si perde nella descrizione di simboli e pratiche.
Sospetto che sia in buona parte un problema d'informazione: difficile dominare appieno un argomento simile, su uno spazio di millenni. Però penso anche che sia, in parte, un problema di struttura: il saggio "umanistico" tradizionale riesce a raccontare bene una storia, ma non è molto adatto a fornire descrizioni complesse. Sarebbe interessante provare a realizzare un prodotto che permetta invece, a colpo d'occhio, dato un segno di punteggiatura, sapere quando è stato introdotto nell'uso, da chi, con quale significato, quali sono state le modifiche successive, e così via... il tutto in modo coerente, da un segno all'altro, e con quadri di descrizione del sistema in determinati momenti.
domenica 4 luglio 2010
Stati di agitazione
Luglio è per me, come lavoro, un mese caldo: correzioni di compiti, tesi di laurea, lavori e progetti da chiudere, ben oltre le otto ore di molti lavori da ufficio... il tutto tenendo come base una stanza in cui l'unica difesa rispetto ai 35° è data da un ventilatorino. Certo, non è come stare tutto il giorno a raccogliere pomodori in un campo in provincia di Latina; ma il punto non è questo. Il punto è che con la manovra finanziaria votata il 15 luglio in Senato, Governo e (, per ora, un ramo del) Parlamento hanno deciso che il "risanamento" dei conti pubblici italiani sarà in buona parte pagato dai dipendenti pubblici. Con particolare attenzione all'università, in cui si congelano gli stipendi per tre anni, senza neanche recupero dell'inflazione - il che equivale a una diminuzione dello stipendio di docenti e ricercatori universitari stimabile, a seconda di come andrà l'inflazione, in un 6-10% da qui al 2013.
E in risposta, quest'estate aderisco alle proteste.
Questo non significa che l'università italiana, così com'è adesso, sia un'entità perfetta da difendere a ogni costo. Tutt'altro. Però non è neanche del tutto disastrosa: continua a formare laureati di buon livello, ricerca, servizi... Lo fa, apparentemente, in modo un po' meno efficiente rispetto alle università di altri grandi paesi europei (anche stime come quelle di Roberto Perotti, piuttosto critiche, parlano in realtà di costi per studente superiori del 10% a quelli di altri paesi europei: non si tratta certo di abissi di follia...). Quanto di questa differenza è responsabilità di chi lavora all'università, e quanto del contesto esterno? Difficile da dire. Io ho le mie idee... ma per chiarire il punto cominciamo con le motivazioni della protesta.
Ora, una cosa che molti esterni ignorano: dal punto di vista di chi lavora al suo interno, l'università italiana è egualitaria per certi aspetti, del tutto arbitraria per certi altri. In che senso? A parità di anzianità e di ruolo, lo stipendio è uguale per tutti: queste sono le tabelle ufficiali dell'Università di Pisa, e il passaggio da un livello di paga al successivo avviene oggi ogni tre anni, mentre fino all'anno scorso avveniva ogni due. Conoscendo ruolo e anzianità di servizio, si può sempre sapere quanto prende (al minimo) un docente.
Le condizioni di lavoro reali, però, sono estremamente diverse. Ci sono università e dipartimenti in cui intere fasce di personale non sono coinvolte nella didattica; e altre in cui le stesse fasce devono lavorare a livelli eccezionali semplicemente per tenere in piedi il corso di laurea cui fanno capo. Oppure, più semplicemente, c'è un'enorme differenza generazionale.
Prendiamo come esempio per quest'ultimo punto due ricercatori: A e B. Non sono persone ben definite, ma rientrano in tipologie ben note a chi lavora all'interno dell'università.
A è entrato in ruolo nel 1982, a meno di trent'anni. Oggi guadagna più o meno sui tremila euro al mese; gentilmente, negli ultimi anni, si è prestato a fare un corso di 30 ore all'anno, e lì si esaurisce il suo impegno didattico. Ogni anno (beh, non tutti-tutti gli anni, ma quasi...) pubblica sulla solita rivista di settore una (una) recensione di una pagina (una) a un libro relativo alla sua disciplina. Ogni tanto segue qualche tesi di laurea, o fa qualche esercitazione. Nel giro di una decina d'anni andrà in pensione, a stipendio praticamente pieno.
B invece è entrato di ruolo da pochi mesi, ma i quarant'anni li ha passati da un pezzo. Oggi, visto che è "in attesa di conferma", prende come stipendio milletrecento euro al mese, e grazie alla legge finanziaria in corso di approvazione rimarrà fermo a questo livello o poco più per quasi sei anni, fino alle soglie della cinquantina. Dopodiché, in mancanza di concorsi e di posti, rimarrà forse ricercatore fino alla pensione - e verso i settant'anni (verso il 2040, incrociando le dita, dovrebbe essere quella l'età del pensionamento) avrà, se va bene, uno stipendio di 2200 euro o giù di lì, destinato a dimezzarsi al momento del pensionamento. Nel frattempo, insegna in due o tre corsi, pubblica, partecipa alle attività amministrative...
Sembrano due mondi diversi, e lo sono. Il primo non è confrontabile con nessuna realtà europea: da nessuna parte si guadagna così tanto, con altrettanta sicurezza, in cambio di così poco. Il secondo è confrontabile come impegni con quelli dei principali paesi europei, ma con una paga decisamente più bassa, e ottenuta a un'età molto più avanzata.
La cosa più carina, però, è un'altra. Uno di questi due ricercatori non rispetta la legge. Ma, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, il trasgressore non è A, è B: i ricercatori italiani hanno limiti precisi a ciò che possono fare - cioè 350 ore al massimo di attività didattica, incluse lezioni, tesi di laurea, esami, correzioni di compiti... e non c'è dubbio che B superi questo limite.
Folle? Non troppo. In fin dei conti il "ricercatore" era previsto come figura giovane, in formazione - l'equivalente di un dottorando (figura che può insegnare, ma entro limiti rigorosi, perché deve principalmente studiare) o di un assegnista di ricerca. Naturale quindi che dovesse dedicare il proprio tempo allo studio, più che alla didattica. Solo che oggi questa figura giovane non è più tale, anagraficamente e come esperienza. Un po' alla volta, l'università italiana ha cominciato ad appoggiarsi ai ricercatori, che oggi, secondo alcune stime, svolgono un po' meno di un terzo della didattica (essendo circa un terzo del personale docente strutturato). La faccenda poi si fa ancora più complicata... ma per le persone interessate ad approfondire, una storia più articolata della faccenda si ritrova in una Riflessione sullo stato giuridico dei ricercatori di Fausto Longo.
Insomma, invece di pagare un professore, oggi di regola si paga un ricercatore - che costa decisamente meno, rispetto a un professore associato oppure ordinario con un minimo di anzianità. Chiudendo un occhio di fronte alle indicazioni della legge. Quindi non c'è nemmeno incentivo a trasformare i ricercatori bravi in professori associati oppure ordinari: in fin dei conti, fanno già lo stesso lavoro, ma costano meno...
Dal punto di vista dei ricercatori, non c'è dubbio che questo sia un male. Lo è anche dal punto di vista dell'università in generale, e del contribuente? A prima vista, potrebbe sembrare di no: si ottiene lo stesso servizio pagando meno. Ma in realtà, un posto alle condizioni di A attira molto; un posto alle condizioni di B attira meno. Un motivo non marginale per seguire la carriera universitaria, fino a una quindicina di anni fa, era il fatto che questo settore, pur pagando poco all'inizio, dava notevole libertà e prometteva stipendi discreti a fine carriera. In alcuni settori, il reclutamento del personale universitario è invece oggi un problema - semplicemente, venute a mancare queste condizioni, il dislivello di paga rispetto all'esterno è troppo forte (non stiamo parlando di gente estratta a caso: stiamo parlando di persone, di regola, di capacità notevoli). Nelle facoltà umanistiche il problema è stato sentito relativamente meno, ma negli ultimi anni sta diventando difficile anche qui trovare persone brave interessate a iniziare la carriera accademica. Non sono ancora sparite, per fortuna - ma rispetto a qualche anno fa la differenza (almeno a me) pare evidente.
E quindi? Rendere più gravoso e meno remunerativo il lavoro, superato un certo livello, diventa controproducente: le persone brave, semplicemente, vanno a fare altro (o, se sono già all'interno, incominciano a pensare che invece di fare il B, potrebbero tutto sommato fare l'A... secondo alcuni dati, quasi un terzo dei ricercatori non ha prodotto nulla dal punto di vista scientifico negli ultimi anni - con, ovviamente, punte massime di inattività tra gli anziani e prepensionandi). Se l'università deve essere solo una fabbrica di pezzi di carta, la cosa non è un problema; se deve essere un'istituzione formativa di buon livello, il problema c'è, eccome.
In questo contesto, l'attuale governo ha già messo limiti agli avanzamenti di carriera e ha ridotto i fondi assegnati all'università; sta ora congelando gli stipendi. Al termine di questo percorso, l'Italia avrà un'università con meno sprechi o un'università con docenti meno bravi e meno motivati? I tagli non tentano nemmeno di distinguere tra chi lavora bene e chi lavora male, e quindi io non ho dubbi sulla risposta. Per questo, appunto, tra un esame e l'altro inizio la protesta.
E in risposta, quest'estate aderisco alle proteste.
Questo non significa che l'università italiana, così com'è adesso, sia un'entità perfetta da difendere a ogni costo. Tutt'altro. Però non è neanche del tutto disastrosa: continua a formare laureati di buon livello, ricerca, servizi... Lo fa, apparentemente, in modo un po' meno efficiente rispetto alle università di altri grandi paesi europei (anche stime come quelle di Roberto Perotti, piuttosto critiche, parlano in realtà di costi per studente superiori del 10% a quelli di altri paesi europei: non si tratta certo di abissi di follia...). Quanto di questa differenza è responsabilità di chi lavora all'università, e quanto del contesto esterno? Difficile da dire. Io ho le mie idee... ma per chiarire il punto cominciamo con le motivazioni della protesta.
Ora, una cosa che molti esterni ignorano: dal punto di vista di chi lavora al suo interno, l'università italiana è egualitaria per certi aspetti, del tutto arbitraria per certi altri. In che senso? A parità di anzianità e di ruolo, lo stipendio è uguale per tutti: queste sono le tabelle ufficiali dell'Università di Pisa, e il passaggio da un livello di paga al successivo avviene oggi ogni tre anni, mentre fino all'anno scorso avveniva ogni due. Conoscendo ruolo e anzianità di servizio, si può sempre sapere quanto prende (al minimo) un docente.
Le condizioni di lavoro reali, però, sono estremamente diverse. Ci sono università e dipartimenti in cui intere fasce di personale non sono coinvolte nella didattica; e altre in cui le stesse fasce devono lavorare a livelli eccezionali semplicemente per tenere in piedi il corso di laurea cui fanno capo. Oppure, più semplicemente, c'è un'enorme differenza generazionale.
Prendiamo come esempio per quest'ultimo punto due ricercatori: A e B. Non sono persone ben definite, ma rientrano in tipologie ben note a chi lavora all'interno dell'università.
A è entrato in ruolo nel 1982, a meno di trent'anni. Oggi guadagna più o meno sui tremila euro al mese; gentilmente, negli ultimi anni, si è prestato a fare un corso di 30 ore all'anno, e lì si esaurisce il suo impegno didattico. Ogni anno (beh, non tutti-tutti gli anni, ma quasi...) pubblica sulla solita rivista di settore una (una) recensione di una pagina (una) a un libro relativo alla sua disciplina. Ogni tanto segue qualche tesi di laurea, o fa qualche esercitazione. Nel giro di una decina d'anni andrà in pensione, a stipendio praticamente pieno.
B invece è entrato di ruolo da pochi mesi, ma i quarant'anni li ha passati da un pezzo. Oggi, visto che è "in attesa di conferma", prende come stipendio milletrecento euro al mese, e grazie alla legge finanziaria in corso di approvazione rimarrà fermo a questo livello o poco più per quasi sei anni, fino alle soglie della cinquantina. Dopodiché, in mancanza di concorsi e di posti, rimarrà forse ricercatore fino alla pensione - e verso i settant'anni (verso il 2040, incrociando le dita, dovrebbe essere quella l'età del pensionamento) avrà, se va bene, uno stipendio di 2200 euro o giù di lì, destinato a dimezzarsi al momento del pensionamento. Nel frattempo, insegna in due o tre corsi, pubblica, partecipa alle attività amministrative...
Sembrano due mondi diversi, e lo sono. Il primo non è confrontabile con nessuna realtà europea: da nessuna parte si guadagna così tanto, con altrettanta sicurezza, in cambio di così poco. Il secondo è confrontabile come impegni con quelli dei principali paesi europei, ma con una paga decisamente più bassa, e ottenuta a un'età molto più avanzata.
La cosa più carina, però, è un'altra. Uno di questi due ricercatori non rispetta la legge. Ma, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, il trasgressore non è A, è B: i ricercatori italiani hanno limiti precisi a ciò che possono fare - cioè 350 ore al massimo di attività didattica, incluse lezioni, tesi di laurea, esami, correzioni di compiti... e non c'è dubbio che B superi questo limite.
Folle? Non troppo. In fin dei conti il "ricercatore" era previsto come figura giovane, in formazione - l'equivalente di un dottorando (figura che può insegnare, ma entro limiti rigorosi, perché deve principalmente studiare) o di un assegnista di ricerca. Naturale quindi che dovesse dedicare il proprio tempo allo studio, più che alla didattica. Solo che oggi questa figura giovane non è più tale, anagraficamente e come esperienza. Un po' alla volta, l'università italiana ha cominciato ad appoggiarsi ai ricercatori, che oggi, secondo alcune stime, svolgono un po' meno di un terzo della didattica (essendo circa un terzo del personale docente strutturato). La faccenda poi si fa ancora più complicata... ma per le persone interessate ad approfondire, una storia più articolata della faccenda si ritrova in una Riflessione sullo stato giuridico dei ricercatori di Fausto Longo.
Insomma, invece di pagare un professore, oggi di regola si paga un ricercatore - che costa decisamente meno, rispetto a un professore associato oppure ordinario con un minimo di anzianità. Chiudendo un occhio di fronte alle indicazioni della legge. Quindi non c'è nemmeno incentivo a trasformare i ricercatori bravi in professori associati oppure ordinari: in fin dei conti, fanno già lo stesso lavoro, ma costano meno...
Dal punto di vista dei ricercatori, non c'è dubbio che questo sia un male. Lo è anche dal punto di vista dell'università in generale, e del contribuente? A prima vista, potrebbe sembrare di no: si ottiene lo stesso servizio pagando meno. Ma in realtà, un posto alle condizioni di A attira molto; un posto alle condizioni di B attira meno. Un motivo non marginale per seguire la carriera universitaria, fino a una quindicina di anni fa, era il fatto che questo settore, pur pagando poco all'inizio, dava notevole libertà e prometteva stipendi discreti a fine carriera. In alcuni settori, il reclutamento del personale universitario è invece oggi un problema - semplicemente, venute a mancare queste condizioni, il dislivello di paga rispetto all'esterno è troppo forte (non stiamo parlando di gente estratta a caso: stiamo parlando di persone, di regola, di capacità notevoli). Nelle facoltà umanistiche il problema è stato sentito relativamente meno, ma negli ultimi anni sta diventando difficile anche qui trovare persone brave interessate a iniziare la carriera accademica. Non sono ancora sparite, per fortuna - ma rispetto a qualche anno fa la differenza (almeno a me) pare evidente.
E quindi? Rendere più gravoso e meno remunerativo il lavoro, superato un certo livello, diventa controproducente: le persone brave, semplicemente, vanno a fare altro (o, se sono già all'interno, incominciano a pensare che invece di fare il B, potrebbero tutto sommato fare l'A... secondo alcuni dati, quasi un terzo dei ricercatori non ha prodotto nulla dal punto di vista scientifico negli ultimi anni - con, ovviamente, punte massime di inattività tra gli anziani e prepensionandi). Se l'università deve essere solo una fabbrica di pezzi di carta, la cosa non è un problema; se deve essere un'istituzione formativa di buon livello, il problema c'è, eccome.
In questo contesto, l'attuale governo ha già messo limiti agli avanzamenti di carriera e ha ridotto i fondi assegnati all'università; sta ora congelando gli stipendi. Al termine di questo percorso, l'Italia avrà un'università con meno sprechi o un'università con docenti meno bravi e meno motivati? I tagli non tentano nemmeno di distinguere tra chi lavora bene e chi lavora male, e quindi io non ho dubbi sulla risposta. Per questo, appunto, tra un esame e l'altro inizio la protesta.
lunedì 28 giugno 2010
Agostino, Ambrogio, Maria, Paolo e Guglielmo

Giovedì mattina sono passato da Milano per faccende editoriali. Naturalmente, con il (giustamente celebre) regionale che parte da Livorno, passa da Pisa Centrale alle 6.08, da San Rossore alle 6.14, e arriva a Milano via Fornovo alle 10.25, attraversando un paesaggio che nelle giornate di bel tempo è meraviglioso. Ritorno alle 17.05, con lo stesso treno: non è certo un Frecciarossa, ma visto che il biglietto a/r costa in totale meno di 34 € a/r, è di gran lunga il modo più ragionevole per passare un'attiva giornata di lavoro nella Capitale Morale (!).
Io ho approfittato dei tempi ferroviari per fare un salto anche in Sant'Ambrogio, dove, in paramenti adeguati al rango, sono adesso di nuovo esposti i resti mortali di, appunto, Sant'Ambrogio. Buona occasione per porsi di nuovo la famosa domanda: quando, milleseicento anni fa, Ambrogio era vivo e leggeva in silenzio, questo suo modo di fare stupiva i contemporanei oppure no? Le venerabili ossa oggi non possono più risponderci. Possono quindi spiegarci qualcosa solo le testimonianze scritte, e in particolare la descrizione fatta da Agostino nelle Confessioni (VI, 3), che da più di cent'anni è al centro dell'attenzione di chi si occupa di questo genere di questioni: "cum [Ambrosius] legebat, oculi ducebantur per paginas et cor intellectum rimabatur, vox autem et lingua quiescebant". Nietzsche, sembra, è stato il primo a ritenere che in queste parole Agostino esprimesse "stupore" davanti alla "stranezza" di Ambrogio, e la sua idea, ripresa da Norden, è diventata negli anni luogo comune. Ma questa ricostruzione corrisponde alla realtà storica?
Mary Carruthers (The book of memory, pp. 170-173) vota per il no. Secondo lei, la descrizione "is often misread" (p. 171); in realtà, nell'antichità classica la meditatio (silenziosa) su un testo conviveva con la lectio (ad alta voce) rivolta agli altri (p. 170). In questo contesto, ciò che sorprende Agostino non è la lettura silenziosa di per sé, quanto piuttosto il fatto che "Ambrose never red in the other way, though others were present ("et aliter numquam")" (p. 171). Secondo Agostino, Ambrogio poi si comportava così soprattutto per evitare interruzioni e domande da parte delle persone che aveva intorno. Quel che contava, insomma, era il fatto che anche in presenza d'altri Ambrogio preferiva "meditare" in silenzio: una questione d'atteggiamento più che di capacità. "Whether or not the vocal chords are used is a secondary difference between the two methods of reading" (p. 172).
A questo discorso replica negativamente Paul Saenger: la meditazione silenziosa su un testo, senza muovere la lingua, secondo lui, non era possibile di fronte a una scrittura priva di spazi tra le parole, come quella che Ambrogio si trovava di fronte. "When Carruthers translates comments on this passage in The Book of Memory, pp. 170-171, she projects o the text attitudes that are entirely postclassical. No ancient writer ever refers to reading as 'scanning' or meditatio" (p. 299, n. 41). Osservazione che mi sembra un po' fuori bersaglio, perché la meditatio di cui parla Mary Carruthers corrisponde in buona parte all'assimilazione di un testo, non alle attività di "rapid, silent reference consultation as it exists in the modern world", secondo la definizione dello stesso Saenger (p. 9).
Chi ha ragione? William A. Johnson ha pubblicato una sintesi delle discussioni su questo argomento, nella prospettiva dei classicisti, in Toward a Sociology of Reading in Classical Antiquity, The American Journal of Philology, vol. 121, 4 (Winter, 2000), pp. 593-627 (disponibile attraverso JSTOR):
Without hesitation we can now assert that there was no cognitive difficulty when fully literate ancient readers wished to read silently to themselves, and that the cognitive act of silent reading was neither extraordinary nor noticeably unusual in antiquity. This conclusion has been known to careful readers since at least 1968, when Bernard Knox demonstrated beyond reasonable doubt that the silent reading of ancient documentary texts, including letters, is accepted by ancient witnesses as an ordinary event (p. 593).
Questo smentisce in buona parte la ricostruzione della linea-Nietzsche, in cui si colloca anche Saenger. Alla critica del libro di Saenger, in effetti, Johnson dedica il dovuto spazio (pp. 597-598) nella sua sintesi: gli antichi acculturati, se volevano, potevano benissimo leggere senza muovere le labbra. Sembra che questo debba chiudere il dibattito.
La risposta finale, però, è più sfumata. In effetti, dice Johnson, esistono tipi molto diversi di lettura. I dati oggi disponibili mostrano che gli antichi erano capaci di leggere in silenzio. Ma mostrano anche che la lettura silenziosa non era, probabilmente, il modo normale di lavoro. Plinio il giovane, per esempio, descrive senza troppi moti di sorpresa il modo in cui Plinio il vecchio, per studiare, si faceva leggere ad alta voce da servitori e segretari mentre mangiava, mentre faceva il bagno, e così via (pp. 605-606). Comportamento oggi impensabile per qualunque studioso serio, e non solo per mancanza di schiavi... Nei paesi di lingua inglese esiste, certo, un florido mercato di audiolibri, ma solo per narrativa o saggi divulgativi, e non certo per i professionisti.
Insomma, forse non esistevano ostacoli invalicabili alla lettura silenziosa, ma di sicuro le modalità di uso e consumo della lettura erano profondamente differenti dalle nostre, e molto caratterizzate socialmente (Johnson insiste molto sul carattere di "attività di prestigio" che aveva la lettura). Anche se smentisce le posizioni più estreme sulla lettura, più che formule risolutive, insomma, l'articolo fornisce stimoli per la ricerca - il che non è un male.
venerdì 25 giugno 2010
Recensione: Corpus linguistics and the web

Una mia breve (3 pagine) recensione del libro Corpus linguistics and the web è stata pubblicata dalla rivista Language resources and evaluation (volume 44, n. 3, settembre 2010, pp. 291-293).
Cosa un po' curiosa per una pubblicazione elettronica, per una serie di eventi la recensione non è troppo di attualità: il libro recensito è uscito nel 2007 e a sua volta presentava contributi realizzati per un convegno del 2003; e, sull'argomento, una distanza di questo tipo pesa! Comunque, più che gli stessi contenuti, in questo caso mi sembra interessante segnalare un po' di aspetti collegati alla pubblicazione.
Innanzitutt, l'accesso è a pagamento, il che significa che chi si collega alla rivista da un'istituzione che ha attivato l'abbonamento al pacchetto di riviste Springer (per esempio, la rete universitaria di Pisa) può leggere e scaricare l'articolo senza problemi, mentre chi si collega in altro modo ha solo la possibilità di acquistare l'accesso pagando 34 dollari. Le condizioni di pubblicazione prevedono però che l'autore possa autoarchiviarsi una copia del Pdf (cosa che ho subito fatto), e metterlo a disposizione in qualche forma (e su questo, ho bisogno di studiarmi la documentazione...).
venerdì 18 giugno 2010
Gawande, The checklist manifesto

Qualche tempo fa, sul treno, ho incontrato un australiano che leggeva The checklist manifesto (pubblicato nel 2010 da Atul Gawande). Gli ho chiesto com'era, e lui ha risposto: "buono". A quel punto, ho spostato il libro un po' più su nella lista delle cose da leggere. Per qualche ragione che non riesco più a ricordare, poi, l'ho comprato nell'edizione su carta. Era chiaramente il tipo di libro che si legge meglio su iPhone e Kindle, ma tant'è... E quindi a inizio settimana mi è arrivato, e l'ho letto al volo.
Giudizio finale: interessante ed equilibrato, anche se poco approfondito dal punto di vista scientifico. Gawande è un chirurgo e, ispirato dagli esempi dei piloti d'aereo e dei costruttori di edifici complessi, si è messo a sperimentare semplici sistemi per migliorare l'esito delle operazioni chirurgiche. Non sorprendentemente, la sua proposta di base consiste nell'usare checklist, o liste di controllo, da leggere ad alta voce o su cui fare segni a penna, per confermare che i vari passi di una procedura siano stati eseguiti correttamente. Anzi, in verità, si tratta di due proposte diverse: usare liste di controllo per assicurare che i passi di base di routine vengano eseguiti tutti, e su questa base costruire una comunicazione all'interno dei gruppi di lavoro che consenta di intervenire in modo coordinato nei casi in cui la routine da sola non basterebbe.
Sul perché questi sistemi funzionano - e, a monte, sul perché la nostra memoria ci tradisce - Gawande ha poco da dire, e più che altro rimanda a nozioni diffuse. Sul modo in cui le istruzioni sono scritte, l'unico consiglio in pratica consiste nella raccomandazione di tenere le liste semplici e valutare con attenzione il rapporto costi-benefici, com'è giusto che sia. L'aspetto interessante del libro è quindi la descrizione di singoli casi di successo. E, in particolare, del modo in cui l'introduzione di liste di controllo da percorrere in pochi secondi ha mostrato una notevole capacità di ridurre le complicazioni in sala operatoria.
Sarà vero? Di sicuro suona molto plausibile; così come sembra plausibile il fatto che, a volte, eseguire controlli di questo genere porta addirittura a ridurre il tempo necessario a portare a termine una procedura complessa, anziché allungarlo. Insomma, anche in questo caso la capacità di scrivere qualche riga di istruzioni può avere un impatto positivo e misurabile sul modo in cui funzionano le cose - perfino in contesti in cui si tratta di fare la differenza, letteralmente, tra la vita e la morte.
giovedì 10 giugno 2010
Zotero
 Per il mio prossimo lavoro sull'italiano del web ho iniziato a gestire la bibliografia usando Zotero: un sistema sviluppato dalla George Mason University, distribuito con licenza GPL3 e adatto a gestire informazioni bibliografiche di diverso tipo. In sostanza, si scheda un articolo o un libro o un sito web con un plugin di Firefox, poi si trascina l'iconcina che rappresenta l'articolo in, per esempio, Writer di Open Office, e i dati bibliografici vengono trascritti.
Per il mio prossimo lavoro sull'italiano del web ho iniziato a gestire la bibliografia usando Zotero: un sistema sviluppato dalla George Mason University, distribuito con licenza GPL3 e adatto a gestire informazioni bibliografiche di diverso tipo. In sostanza, si scheda un articolo o un libro o un sito web con un plugin di Firefox, poi si trascina l'iconcina che rappresenta l'articolo in, per esempio, Writer di Open Office, e i dati bibliografici vengono trascritti.In aggiunta al meccanismo base, Zotero ha anche diverse funzioni interessanti, che lo rendono preferibile ad archivi più artigianali. Per esempio, regolando le opzioni del programma si possono salvare le citazioni in diversi formati, il che è comodo quando (come spesso accade) le stesse opere base devono essere citate in dieci articoli diversi, con dieci criteri diversi di presentazione. Apparentemente, sta diventando la cosa più vicina a uno standard che sia disponibile in questo settore.
È ancora presto per capire se il sistema può andar bene per me, ma di sicuro qualche funzione integrata comincia a essere interessante. Per esempio, per gli articoli inseriti su JSTOR e alcune altre fonti non occorre digitare a mano i dati bibliografici (autore, titolo, rivista...): nella barra dell'indirizzo di Firefox compare un'iconcina che, cliccata, trascrive direttamente i dati in Zotero. I siti che offrono questo genere di indicizzazione sono ancora pochi, ma spero che crescano... In fin dei conti, prima o poi uno standard dovrà pure emergere!
mercoledì 9 giugno 2010
Sassetti, Lettere dall'India
Mi sono preso un po' di pausa da spazi e segni d'interpunzione per leggere le Lettere dall'India (1583-1588) del fiorentino Filippo Sassetti, a cura di Adele Dei, Roma, Salerno ed., 1995. Ne valeva la pena...
In fin dei conti, Filippo Sassetti è uno che a fine Cinquecento fece una scelta niente male, cioè, si mise in testa di andare in India. Per lavoro (come sovrintendente alle spedizioni di pepe di Giovan Battista Rovellasco), ma anche e soprattutto per interesse personale: per andare a vedere il mondo. In realtà, quel che vide fu soprattutto qualche insediamento costiero portoghese (Cochin e Goa) sulla costa del Malabar, e in un periodo di crisi, perlopiù. Ma, visto che fece un figlio sul posto, Sassetti non si trovò poi troppo male; e anche a fine soggiorno progettava di tornare in patria facendo il giro del mondo - Indonesia, Cina, Giappone, America. La morte lo colse prematuramente e gli impedì di portare a compimento il viaggio; ma d'altra parte, Sassetti sapeva i rischi che correva, e non era poi che in patria la vita fosse molto più lunga. Non irragionevolmente, alla sorella che lo invitava al rientro, rispondeva quindi il 27 gennaio del 1585:
... la ragione del "ricordarmi d'essere nato a Firenze" non è buona, ché se delle due cose [cioè, evidentemente, nascere e morire] vi se ne fa una, basta. Se voi mi diceste: "A Firenze non si muore", questo sì mi farebbe tornare trottando (p. 96).
Ma, decisamente, non era così: le lettere che arrivavano (una volta all'anno, con l'arrivo delle navi da Lisbona tra settembre e novembre) gli portavano notizie di lutti continui. A Francesco Valori, che gli faceva elenchi di "Gente morta", Sassetti rispondeva dicendo: "Almeno mi aveste voi dato il contraccambio di tanti bambini nati, acciò che io non argomentassi che voi fosse costà venuti a finimondo" (p. 88). E in parallelo si rivolgeva agli appassionati di viaggi e descrizioni esotiche, come Michele Saladini a Pisa, cui scriveva nel dicembre 1585:
... ho molto contento a comprendere dal vostro scrivere che voi vi siate dato alla cosmografia. Parmi che manchi poco, per certa regola che abbiamo determinato qua il signor Pietro Grifo ed io di quello che bisogna a tirar gli uomini a India, a vedervici una volta comparire (p. 120).
Insomma, già allora il mal d'India era una malattia contagiosa... Colpisce, comunque, il modo in cui Sassetti continua a immischiarsi di faccende di casa, ricordando e consigliando dal Malabar campi e ville a Carmignano o a Campi Bisenzio. O mettendosi a paragonare le palafitte indiane agli "sporti di Santa Croce, che fanno quella bella vista quando e' si giuoca al calcio e sono le finestre piene di belle donne" (p. 98)... E il racconto non è male, anche se lo stile fiorentino ribobolaio dell'epoca, pieno di modi del parlato e di doppi sensi, spesso non rende facile la lettura (e fa venire la tentazione di correggere e semplificare ogni riga). Il commento di Adele Dei (che per il testo si basa sull'edizione di Bramanti, 1970, aggiungendo pochissimo di suo) aiuta un po', ma ogni tanto si svia - per esempio, a p. 90 probabilmente non si parla di "malattie veneree", ma di semplice elefantiasi (di cui Sassetti aveva già parlato a p. 86). Ma tant'è; nel groviglio di osservazioni e battute, qualcosa si perde per forza.
Dal punto di vista più strettamente linguistico, Sassetti è tra i primi a importare in italiano un bel po' di parole esotiche, da bambù a mango. Però, soprattutto, sembra sia stato il primo a citare in Europa l'esistenza del sanscrito:
Sono scritte le loro [= degli indù] scienze tutte in una lingua, che dimandano sanscruta, che vuol dire "bene articolata", della quale non si ha memoria quando fusse parlata, con avere (com'io dico) memorie antichissime. Imparanla come noi la greca e la latina e vi pongono molto maggior tempo, sì che in sei anni o sette se ne fanno padroni: e ha la lingua d'oggi molte cose comuni con quella, nella quale sono molti de' nostri nomi, e particularmente de' numeri el 6, 7, 8 e 9, Dio, serpe, e altri assai (lettera a Bernardo Davanzati del 22 gennaio 1586, pp. 179-180).
Insomma, Sassetti notò la somiglianza di ruolo tra il sanscrito, il latino e il greco ("parmi che noi possiamo dire che sia infermità di questo secolo che in tutte le parti del mondo le scienze sieno in lingua differente da quella che si parla", precisa altrove), ma non la stretta parentela . Nel brano citato si limita a notare la somiglianza di alcune parole con l'italiano (non con "il greco e il latino", come dice la curatrice, a p. 15), e più avanti citerà i nomi di città che finiscono in poli, per somiglianza con il greco. Stop. Per chiarire meglio la situazione ci vollero altri due secoli, ma nel contesto Sassetti non fa affatto una cattiva figura, visto che ai tempi suoi i portoghesi erano in India da un secolo e non si erano degnati di informarsi poi molto su usi e costumi locali. E in fin dei conti, difficile parlar male di uno che decise di imbarcarsi così, e che a Pier Vettori poteva raccontare con partecipazione (27 gennaio 1585, pp. 76-77) di "un uomo da bene che sta in queste parti", il quale
... avendo moglie e figli in Lisbona, e vivendosi acconciamente, si trovava una mattina su la riva del mare a veder partire le navi che vengono qua; allo sciorre delle vele delle quali, tutti i marinai, passeggieri, soldati e tutta la terra finalmente grida a voci altissime "Buon viaggio", al qual grido sentitosi quello uomo buono toccare il cuore, aperta la borsa e trovatovi drento sei portoghesi, che sono circa novanta ducati, mandò a dire a casa che non l'aspettassino a desinare...
martedì 8 giugno 2010
Oltre i trecento

Ieri Steve Jobs ha presentato in anteprima l'iPhone 4. Il racconto della presentazione fatto da Rob Beschizza per BoingBoing (da dove riprendo anche l'immagine qui sopra, realizzata da Dean Putney) dà il giusto risalto a un aspetto non marginale, cioè
the gadget's new high-resolution display, which offers 4x the screen resolution compared to the current model. This feature (...) means that the screen has 326 pixels per inch, denser even than the dots per inch of some printed material.
Non è un risultato da poco! Fino a oggi, tutti gli schermi per computer o assimilabili (a tubo catodico, LCD, a inchiostro elettronico...) fornivano una risoluzione inferiore ai 300 punti per pollice che sono da più di vent'anni lo standard di stampa anche dei prodotti di fascia bassa.
Beschizza, come commento, aggiunge che "Typographers and artists will doubtless be pleased at the possibilities" offerte dall'iPhone. In effetti...
Certo, la stampa professionale arriva a risoluzioni di 1300 punti per pollice, e per un'immagine ricca di dettagli (da una fotografia a una carta geografica) la differenza rimarrà fortissima, a tutto vantaggio della carta. Però, per molti contesti lavorativi, si può dire che almeno su questo punto, finalmente, lo schermo supera la carta. E, con la diffusione di questi schermi, diventeranno inutili i criteri del tipo "su schermo, i caratteri senza grazie sono più leggibili di quelli con grazie", eccetera.
lunedì 7 giugno 2010
La forma delle parole

Nei miei corsi mi trovo spesso a presentare una contrapposizione: da un lato il modo in cui noi immaginiamo di leggere, dall'altro il modo in cui leggiamo davvero.
In sostanza, spesso noi crediamo che la nostra lettura funzioni decifrando una lettera dopo l'altra. Incontriamo una lettera, la "leggiamo", la mettiamo in memoria e passiamo alla successiva. Tot lettere formano una parola, e così via.
I meccanismi mentali reali, invece, sono molto più complessi. Io li presento in forma molto semplificata, accennando al fatto che il cervello lavora su molti binari contemporaneamente - per esempio, tenendo in considerazione il senso della frase fino a quel punto per fare ipotesi ragionevoli su come deve continuare la parola, e così via.
Ma in che modo funzionano, questi meccanismi, in dettaglio? Qui le cose si fanno più vaghe e l'informazione spesso contraddittoria. Facendo i controlli di contesto sul solito Space between words ho trovato un interessante articolo di Kevin Larson: The Science of Word Recognition, or, how I learned to stop worrying and love the bouma. L'articolo fa parte dei lavori del gruppo di ricerca Microsoft sulla "tipografia" (cioè, in sostanza, sulla presentazione dei testi dal punto di vista del carattere), ed è una critica decisa delle informazioni fornite da Saenger sul modo di riconoscimento delle parole.
Larson dichiara innanzitutto che leggendo Saenger, "I learned to my chagrin that we recognize words from their word shape and that “Modern psychologists call this image the ‘Bouma shape’”". La ricostruzione non è del tutto corretta: il virgolettato nel virgolettato viene sì dal libro di Saenger (p. 19), ma lì non si dice affatto che i normali lettori riconoscono le parole in base alla loro forma! Saenger in effetti si limita a ricordare che "the student of the history of reading in the medieval West is primarily concerned with the evolution of word shape" (p. 18); anche in altri punti del libro cita la "Bouma shape" delle parole, ma, mi sembra, senza mai dire che questo è l'unico (o anche solo il principale) strumento che il lettore usa per riconoscere le parole. Cosa che corrisponde all'esperienza quotidiana: chi mai può sostenere che basti vedere per esempio questa forma:

... per ricondurla alla parola shape? (Per inciso, sia questa immagine sia quella presentata a inizio post vengono dall'articolo di Larson).
Detto questo, non c'è dubbio che un'ampia tradizione di ricerca e insegnamento (in cui mi inserisco anch'io) abbia dato molta importanza alla "forma" delle parole. Il discorso di Larson si fa più interessante quando va proprio contro questa tradizione, che ha diversi punti di forza. Quelli che cito spesso anch'io, e che sono confermati da molti studi, sono:
1. la maggiore velocità di lettura permessa dal testo in minuscole rispetto al testo in tutto maiuscole;
2. la difficoltà di individuare gli errori di battitura, soprattutto se compatibili con la forma "corretta" della parola (per esempio, crlpa invece di colpa - mentre è più facile individuare cqlpa).
Al primo punto, Larson risponde che:
This is entirely a practice effect. Most readers spend the bulk of their time reading lowercase text and are therefore more proficient at it. When readers are forced to read large quantities of uppercase text, their reading speed will eventually increase to the rate of lowercase text. Even text oriented as if you were seeing it in a mirror will quickly increase in reading speed with practice (Kolers & Perkins, 1975).
L'articolo di Kolers e Perkins cui si fa riferimento è questo, e spero di leggermelo presto (e, perché no, di controllare i risultati).
Al secondo punto, Larson risponde indicando un errore di metodo in uno degli studi più importanti e citati sull'argomento, e indicando uno studio successivo più accurato:
Haber & Schindler (1981) found that readers were twice as likely to fail to notice a misspelling in a proofreading task when the misspelling was consistent with word shape (tesf, 13% missed) than when it is inconsistent with word shape (tesc, 7% missed). This is seemingly a convincing result until you realize that word shape and letter shape are confounded. The study compared errors that were consistent both in word and letter shape to errors that are inconsistent both in word and letter shape. Paap, Newsome, & Noel (1984) determined the relative contribution of word shape and letter shape and found that the entire effect is driven by letter shape.
Anche qui, spero di poter leggere la bibliografia in tempi brevi!Certo, dal punto di vista delle indicazioni pratiche da fornire nei corsi di scrittura, la sintesi di Larson, anche se fosse corretta, sposterebbe ben poco: il testo in minuscole rimane più leggibile di quello in maiuscole, per i normali lettori occidentali. Mi chiedo però se dalla pari leggibilità potenziale del minuscolo e del maiuscolo non si possa ricavare qualche meccanismo pratico interessante! Ammesso che sia vera, è ovvio.
In ogni caso, a parte la critica delle posizioni altrui, è interessante chiedersi come funzioni davvero la lettura. Larson sposa il modello della "parallel letter recognition": non l'ho ancora capito a sufficienza da poter dire quanto assomiglia ai modelli un po' generici che spesso usano i linguisti (tipo me...) e che sembrano piuttosto robusti dal punto di vista pratico. Tuttavia, sono sicuro che anche da questa angolazione possano venire fuori ispirazioni interessanti.
mercoledì 2 giugno 2010
Lettere e immagini
Ho finito di leggere Space between words di Paul Saenger e adesso lo sto schedando e controllando. Come spesso accade, poi, i controlli sono interessanti quanto e più del testo in sé... Alla fine, mi sono messo a leggere il testo in parallelo a Pause and effect di M. B. Parkes (1992), di cui spero di parlare più avanti, e il confronto mi ha chiarito diverse cose.
Una prima nota, intanto, serve a ricordare che su un argomento di paleografia, il corredo di immagini, cioè di riproduzioni di manoscritti, è determinante. Eppure le riproduzioni, in entrambi i libri, hanno diversi limiti
Innanzitutto, nel libro di Saenger sono relativamente poche, e poco curate. Trentaquattro in tutto, e l'ultima, presentata a p. 229, è pure stampata male, essendo invertita specularmente. Errore che tra l'altro fa capire che il testo riprodotto non era poi molto leggibile, a colpo d'occhio... chissà quanti si saranno accorti dell'inversione? In altri casi (per esempio, nelle figg. 24, 27, 28) vengono riportate sezioni dell'originale in taglio un po' approssimativo, che nasconde parti di lettere (tratto comune al libro di Parkes), e in altri ancora la riproduzione è sfocata o sgranata.
In secondo luogo, le caratteristiche fisiche dei volumi pongono limiti precisi. Le dimensioni del libro di Saenger sono quelle del saggio umanistico tradizionale: 22,7 x 15 cm, cioè 340 centimetri quadrati, cioè un'area molto ridotta, rispetto a quella di diversi manoscritti fonte. La qualità fotografica e quella tipografica, come già detto, non sono di livello eccelso, e il supporto, normale carta porosa, peggiora ulteriormente la situazione. Per fortuna, in molti casi il fenomeno descritto si individua bene anche attraverso questi ostacoli - ma la leggibilità non è certo alta. Nel libro di Parkes la qualità delle riproduzioni è molto superiore, così come lo sono la carta (patinata) e le dimensioni (27,4 x 21,5 cm, cioè un'area quasi doppia, con 590 centimetri quadrati); anche qui, però, siamo spesso ben lontani dalle misure degli originali.
Le caratteristiche fisiche, inoltre, non sono tutto: Parkes accosta alle proprie riproduzioni anche trascrizioni del testo originale, traduzioni, note e numeri di riga, il che rende molto più semplice l'individuazione dei tratti commentati. Niente di tutto questo in Saenger. Beninteso, per fortuna in quest'ultimo libro buona parte dei testi riprodotti è scritta in latino, e in grafie che, essendo anteriori al XIII secolo, sono di solito molto leggibili. Però, per esempio, la fig. 9 dovrebbe illustrare la presenza di "hierarchical word blocks in the English translation of Orosius's Seven Books Against the Pagans" (p. 42), con spazi relativamente ampi usati solo per separare parole e spazi relativamente ridotti usati sia per separare parole sia per separare sillabe con valore di morfemi. Benissimo... solo che il manoscritto resta, per lingua e per grafia, ben poco accessibile a lettori come me: la trascrizione del testo originale avrebbe permesso di verificare meglio l'affermazione.
Soprattutto, infine, in nessuno dei due libri le immagini vengono elaborate per facilitare l'individuazione dei fenomeni. Saenger presenta alcuni ingrandimenti di particolari sezioni dei testi, il che è già un passo avanti rispetto alle pagine intere. Poi però non ci sono frecce, indicatori, evidenziazioni... Il che contribuisce a rendere frequenti situazioni come quella che ho già descritto qualche settimana fa: si cerca di verificare un dettaglio e non ci si riesce. Isolare una riga di testo e accompagnarla con frecce in cui si indicano i caratteri o i fenomeni cui si fa riferimento: non è difficile, però qui non viene fatto.
Come mai accettiamo d'abitudine questi difetti in lavori specialistici di questo tipo - e, aggiungo, di questa qualità? Alla radice, penso che sia solo perché la tecnologia tipografica ancora oggi si fonda su una separazione radicale tra chi scrive e chi impagina, e ancor più tra chi scrive e chi gestisce le immagini. E poi, possiamo dare per scontato che chi studia manoscritti medievali non sappia usare, per esempio, Photoshop. O no?
Una prima nota, intanto, serve a ricordare che su un argomento di paleografia, il corredo di immagini, cioè di riproduzioni di manoscritti, è determinante. Eppure le riproduzioni, in entrambi i libri, hanno diversi limiti
Innanzitutto, nel libro di Saenger sono relativamente poche, e poco curate. Trentaquattro in tutto, e l'ultima, presentata a p. 229, è pure stampata male, essendo invertita specularmente. Errore che tra l'altro fa capire che il testo riprodotto non era poi molto leggibile, a colpo d'occhio... chissà quanti si saranno accorti dell'inversione? In altri casi (per esempio, nelle figg. 24, 27, 28) vengono riportate sezioni dell'originale in taglio un po' approssimativo, che nasconde parti di lettere (tratto comune al libro di Parkes), e in altri ancora la riproduzione è sfocata o sgranata.
In secondo luogo, le caratteristiche fisiche dei volumi pongono limiti precisi. Le dimensioni del libro di Saenger sono quelle del saggio umanistico tradizionale: 22,7 x 15 cm, cioè 340 centimetri quadrati, cioè un'area molto ridotta, rispetto a quella di diversi manoscritti fonte. La qualità fotografica e quella tipografica, come già detto, non sono di livello eccelso, e il supporto, normale carta porosa, peggiora ulteriormente la situazione. Per fortuna, in molti casi il fenomeno descritto si individua bene anche attraverso questi ostacoli - ma la leggibilità non è certo alta. Nel libro di Parkes la qualità delle riproduzioni è molto superiore, così come lo sono la carta (patinata) e le dimensioni (27,4 x 21,5 cm, cioè un'area quasi doppia, con 590 centimetri quadrati); anche qui, però, siamo spesso ben lontani dalle misure degli originali.
Le caratteristiche fisiche, inoltre, non sono tutto: Parkes accosta alle proprie riproduzioni anche trascrizioni del testo originale, traduzioni, note e numeri di riga, il che rende molto più semplice l'individuazione dei tratti commentati. Niente di tutto questo in Saenger. Beninteso, per fortuna in quest'ultimo libro buona parte dei testi riprodotti è scritta in latino, e in grafie che, essendo anteriori al XIII secolo, sono di solito molto leggibili. Però, per esempio, la fig. 9 dovrebbe illustrare la presenza di "hierarchical word blocks in the English translation of Orosius's Seven Books Against the Pagans" (p. 42), con spazi relativamente ampi usati solo per separare parole e spazi relativamente ridotti usati sia per separare parole sia per separare sillabe con valore di morfemi. Benissimo... solo che il manoscritto resta, per lingua e per grafia, ben poco accessibile a lettori come me: la trascrizione del testo originale avrebbe permesso di verificare meglio l'affermazione.
Soprattutto, infine, in nessuno dei due libri le immagini vengono elaborate per facilitare l'individuazione dei fenomeni. Saenger presenta alcuni ingrandimenti di particolari sezioni dei testi, il che è già un passo avanti rispetto alle pagine intere. Poi però non ci sono frecce, indicatori, evidenziazioni... Il che contribuisce a rendere frequenti situazioni come quella che ho già descritto qualche settimana fa: si cerca di verificare un dettaglio e non ci si riesce. Isolare una riga di testo e accompagnarla con frecce in cui si indicano i caratteri o i fenomeni cui si fa riferimento: non è difficile, però qui non viene fatto.
Come mai accettiamo d'abitudine questi difetti in lavori specialistici di questo tipo - e, aggiungo, di questa qualità? Alla radice, penso che sia solo perché la tecnologia tipografica ancora oggi si fonda su una separazione radicale tra chi scrive e chi impagina, e ancor più tra chi scrive e chi gestisce le immagini. E poi, possiamo dare per scontato che chi studia manoscritti medievali non sappia usare, per esempio, Photoshop. O no?
mercoledì 26 maggio 2010
Kindle, iPad e studio
Siamo sempre a livello di aneddoti, ma un articolo recente mostra ancora una volta i limiti pratici di Kindle e assimilabili quando non si tratta di leggere romanzi, ma di studiare: Amazon.com's Kindle fails first college test di Amy Martinez, pubblicato dal Seattle Times, riferisce di problemi ben noti. Con il Kindle non ci si muove facilmente all'interno di un testo, e non si possono prendere facilmente appunti, eccetera.
Le cose andranno meglio con l'iPad? Forse marginalmente meglio, vista l'interfaccia più sofisticata. Ma dubito che il cambiamento sia tale da non far rimpiangere la carta.
Le cose andranno meglio con l'iPad? Forse marginalmente meglio, vista l'interfaccia più sofisticata. Ma dubito che il cambiamento sia tale da non far rimpiangere la carta.
martedì 25 maggio 2010
Beda il Venerabile salverà il Tibet?

Oggi, 25 maggio, sia la Chiesa cattolica sia quella anglicana festeggiano Beda il Venerabile - uno dei punti di riferimento per il cristianesimo britannico in età altomedievale. A volte Beda viene ricordato come "padre della nota a piè di pagina" (affermazione che richiede un bel po' di precisazioni); il suo ruolo nell'affermazione della divisione delle parole secondo lo standard moderno sembra invece più limitato. Tuttavia, essendo uno dei massimi letterati nel luogo e nel momento in cui sembra affermarsi la divisione moderna delle parole, il suo nome compare spesso anche nel libro di Saenger che sto finendo in questi giorni di leggere e schedare.
Che cosa c'entra il Tibet? Beh, uno degli aspetti più curiosi della storia della scrittura è la riciclabilità dei modelli. Facendo una ricerca in rete sul modo in cui è stato recensito il libro di Saenger, ho scoperto che Space between words viene indicato come punto di riferimento per una riforma della scrittura tibetana. Una studentessa tibetana di Harvard, Tenzin Dickyi, lo cita infatti ampiamente, come ispirazione, in un recente contributo intitolato Breathing Space: How Word Separation Can Save the Tibetan Language in cui si propone una riforma della scrittura tibetana:
Tibetans of our generation do almost all of our reading and writing in a foreign language and almost none in Tibetan. When young Tibetans trained outside the monastic system – who constitute the majority – cannot write a decent letter in Tibetan or read a sentence without tripping over at least three words, we have a crisis at hand. What’s to be done? The root of the problem is quite simple: we cannot write Tibetan well because we almost never read Tibetan, and we almost never read Tibetan because it is so difficult to read it. And there’s one very simple way to immediately ease the difficulty of reading Tibetan: word separation. Adding a space between words so that we can see each word as an immediate discrete unit having visual meaning will simplify the daunting task of reading Tibetan script overnight.
Insomma, rendere più facile la lettura aggiungendo gli spazi tra le parole aiuterebbe a salvare la cultura tradizionale tibetana. Qualche applicazione pratica del principio si trova poi su un altro blog, apparentemente curato dal fratello di Tenzin Dickyi. Ma il meccanismo può servire davvero?
La risposta è complicata, perché i tibetani hanno scelto secoli fa un percorso in salita: pur avendo una lingua molto vicina al cinese, hanno adottato un sistema di scrittura ripreso dall'India. Molti osservatori, incluso Fosco Maraini, sono partiti da questa nota per fare osservazioni di portata generale sulla cultura del Tibet (ne parlavo un paio d'anni fa in un altro post). La Blackwell Encyclopedia of writing systems scritta da Florian Coulmas conferma la difficile situazione. In tibetano, non solo "Syllables are written from left to right one next to another with no word division" e non c'è modo di indicare i toni, ma.
... never having been reformed since the standardization of the orthography during the reign of King Rapalcan (815-36), the spelling conventions of Tibetan are conservative with rather involved grapheme-phoneme correspondences which make for difficult reading... Tibetan exists in a situation of diglossia. Until recently, writing was largely restricted to classical Tibetan. A standard of modern literary Tibetan has emerged in the twentieth century (pp. 502-503).
Insomma, probabilmente Beda il Venerabile da solo non sarà sufficiente. Però purtroppo temevamo una cosa del genere, anche in base ad altri fattori...
venerdì 21 maggio 2010
Cut-up
Oggi ho fatto l'ultima lezione dell'ultimo corso - con un po' di dispiacere, perché quest'anno gli argomenti erano particolarmente interessanti! (Beh, almeno per me...)
Comunque l'ultima lezione di Linguaggio del web si è conclusa con alcuni esempi di cut-up classico nello stile di Brion Gysin e William Burroughs. Per l'occasione, ho anche fatto vedere una curiosa applicazione in linea: la William S. Burroughs' & Brion Gysin's Ncon-Linear Adding Machine. Il titolo rimanda obliquamente all'attività di famiglia dei Burroughs a partire dal 1886: costruire macchine addizionatrici.
Il risultato del cut-up? Non molto leggibile, in effetti. Però non è questo ciò che conta, apparentemente... E in ogni caso, spero sia stato interessante il giochino che abbiamo fatto negli ultimi minuti: prendere un po' di parole ritagliate a caso da un articolo di Cory Doctorow e provare a ricombinarle. Attività che come minimo mostra quanto sia difficile produrre un testo sensato con mezzi puramente meccanici.
E a proposito: aggiungo anche un link alle registrazioni delle poesie di Gysin. Consiglio in particolare I am.
Comunque l'ultima lezione di Linguaggio del web si è conclusa con alcuni esempi di cut-up classico nello stile di Brion Gysin e William Burroughs. Per l'occasione, ho anche fatto vedere una curiosa applicazione in linea: la William S. Burroughs' & Brion Gysin's Ncon-Linear Adding Machine. Il titolo rimanda obliquamente all'attività di famiglia dei Burroughs a partire dal 1886: costruire macchine addizionatrici.
Il risultato del cut-up? Non molto leggibile, in effetti. Però non è questo ciò che conta, apparentemente... E in ogni caso, spero sia stato interessante il giochino che abbiamo fatto negli ultimi minuti: prendere un po' di parole ritagliate a caso da un articolo di Cory Doctorow e provare a ricombinarle. Attività che come minimo mostra quanto sia difficile produrre un testo sensato con mezzi puramente meccanici.
E a proposito: aggiungo anche un link alle registrazioni delle poesie di Gysin. Consiglio in particolare I am.
mercoledì 19 maggio 2010
Roncaglia, La quarta rivoluzione

È appena uscito, e me lo sono comprato al volo, La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro, di Gino Roncaglia.
Il libro è un ottimo testo divulgativo, e ha l'incomparabile vantaggio di essere aggiornato a questa primavera... fino all'annuncio dell'iPad, e prima della sua commercializzazione in Italia. Se si cerca un testo unico sulla questione dei libri elettronici, al momento non c'è niente di meglio in italiano - e niente di immediatamente confrontabile nemmeno in altre lingue. Quindi è una lettura assolutamente consigliata.
A livello di informazioni di contorno, il libro ha anche un sito di riferimento (e un gruppo su Facebook). Il libro è anche come e-book - cosa naturale, ma tutt'altro che scontata - e tra poco dovrebbe comparire anche nel catalogo della nuova sezione ebook di IBS.
Per quanto riguarda i contenuti, le sei "lezioni" presentano, in modo piacevolmente discorsivo, gli argomenti indispensabili. Trasformando i titoli evocativi delle lezioni (per esempio, la prima si intitola Il libro e il cucchiaio) in indicazioni più referenziali, la suddivisione grosso modo sarebbe:
1. caratteristiche delle interfacce di lettura
2. definizione del libro elettronico
3. storia dell'e-book, con molta attenzione ai problemi pragmatici di usabilità
4. codifica dei testi
5. gestione dei diritti e distribuzione
6. prospettive per il futuro
Come sintesi dello stato delle cose, sembra difficile immaginare qualcosa di meglio - o anche semplicemente di diverso (anche se qualcosa di più dirò a fine post). Semplicemente, se si vuole un orientamento intelligente sugli e-book, oggi questo è il libro da cui partire.
Anche a livello di dettaglio, la qualità del lavoro è notevole. La terza "lezione", che nell'originale si intitola Dalla carta allo schermo (e ritorno?), per esempio, rappresenta la miglior storia dell'e-book che abbia letto finora, in qualunque lingua: non solo per copertura e livello di dettaglio, ma soprattutto per la selezione delle cose da dire - quelle importanti, in sostanza!
Limiti del testo? Una volta detto che il libro è assolutamente consigliato, proprio la minima portata delle osservazioni che si possono fare rende l'idea di quanto sia ben fatto il lavoro. Per esempio, a p. 127, a proposito di codifica di testo, si parla di marcatori testuali che, si dice, "vengono convenzionalmente inseriti fra una coppia di parentesi chiuse". Vero per alcuni linguaggi, molto meno per altri - a cominciare dai formati per descrivere le pagine! Oppure a p. 151: di un programma come "Kindle for iPhone" si dice che "non è certo all'altezza di programmi come Stanza". Sicuro? Meno versatile, senz'altro, ma la qualità tipografica e di interazione mi sembra come minimo paragonabile, se non superiore. A p. 141 si parla del lettore Blio come se già fosse disponibile, e invece non lo è...
Insomma, dettagli minimi all'interno di un libro importante. Che cosa poteva esserci di più, e non c'è? Direi semplicemente una cosa - fondamentale, ma su cui in effetti la riflessione oggi è molto indietro: la descrizione dei motivi e delle tecniche per cui si legge. Qualcosa si trova, sparso nel testo, ma sono accenni che per lo più ruotano attorno a una distinzione un po' troppo schematica, quella tra fruizione lean back (rilassata) e lean forward (tipica di chi lavora con un testo, correggendo, scrivendo, etc.). Su questo punto anche le osservazioni sembrano un po' arretrate. Alle pp. 93-94 viene riportato, per criticarlo, un luogo comune legato "alla testualità elettronica":
quello secondo cui la fruizione digitale può funzionare per opere di reference, e non può invece funzionare per la letteratura e le opere che corrispondono a grandi linee alla categoria editoriale della 'varia': saggistica e divulgazione caratterizzate da un impianto fondamentalmente lineare e da una struttura comunque in qualche misura narrativa.
La critica a questo luogo comune viene fatta da Roncaglia sulla base dei prevedibili sviluppi futuri. Ma in effetti già dal 2007 il successo del Kindle ha mostrato che la narrativa e la 'varia' si leggono benissimo sui libri elettronici. È la lettura a fondo, per ragioni di studio, che crea problemi: annotazione, schematizzazione di testi, e così via. Insomma, su questo punto la realtà è già andata avanti rispetto alle nostre discussioni - e la prossima sfida del mercato, a me, sembra esattamente questa: produrre soluzioni hardware e software che si possano usare per il lavoro, non solo per la lettura rilassata.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)













